You are currently browsing the tag archive for the ‘distopia’ tag.
E adesso il Commissario giaceva immobile ai suoi piedi, il volto incrostato di sangue e di fango come la sua inconfondibile divisa d’ordinanza, un completo di foggia severa, quasi militare. Il kipple strisciava intorno al suo corpo in grigie volute cariche di cenere a ghermirne le membra.
Duecento metri più in là, all’estremità opposta della spianata, dalla distesa di macerie e detriti del Limbo emergeva la mole pesante e tetra della Fornace.
La vista del luogo, diversamente da quanto lui stesso si sarebbe aspettato, non respinse Briganti, né lo sprofondò nel turbine di dolore che continuava a rimestare i suoi ricordi. Il tenente restò immobile al cospetto della struttura, più imponente di quanto ricordasse. La Fornace era formata da un blocco centrale di tre navate alte tre piani, che culminavano in un tetto spiovente, la classica fabbrica costruita nel cuore dell’era industriale e scampata per miracolo ai bombardamenti, alle crisi, ai terremoti e alle eruzioni, per trasformarsi in una triste reliquia di archeologia urbana. I mattoni rossi delle pareti si erano consumati e ingrigiti. La malta era diventata nera per l’usura degli agenti atmosferici e dei vapori vulcanici. Le arcate delle finestre collassate erano orbite nere, delimitate dagli artigli di lastre di vetro. Tre ciminiere si protendevano fiere ma spettrali dal lato corto opposto all’entrata principale, vedette spettrali contro il cielo grigio della Cintura, in attesa dell’alba.
Briganti vide ombre muoversi nel chiarore attenuato e polveroso che filtrava dalle aperture. Ombre lunghe, come di monaci incappucciati o dottori della peste, che emergevano dai corridoi bui dei suoi incubi peggiori e scivolavano fuori dalla vista dietro i bordi delle alte finestre ad arco. Le ginocchia arrugginite e paralizzate, proprio come due anni e mezzo prima, quando era rimasto impietrito davanti al corpo esanime di Simona, il pensiero incapace di rimettersi in moto. Il flash di un volto un tempo familiare, ormai privo di vita e di espressione, gli attraversò la mente con la facilità di una lama incandescente. Anche il dolore fu lo stesso.
– Tutto bene, signore?
La voce di un tecnico della Scientifica lo richiamò nel mondo dei vivi.
Primo contatto con il kipple di dickiana memoria, in Ricordi proibiti (Delos Digital, 2024).

L’articolo che avevo annunciato è online da alcuni giorni su Quaderni d’Altri Tempi. È un pezzo a cui tengo molto e che allo stesso tempo avrei preferito non dover scrivere.
L’idea che gli Stati Uniti d’America potessero sfaldarsi in una costellazione di entità indipendenti sembrava fino a solo pochi anni fa un pretesto per uno scenario distopico di fantascienza a buon mercato. Non solo la più potente, ma per la forza del suo impatto sull’immaginario comune e per la sua influenza sulla percezione delle persone, sui cittadini dei posti più remoti della Terra, anche la più grande nazione al mondo, un paese in cui tutti vorrebbero (o avrebbero voluto) vivere. Il cuore dell’Impero, a cui noi che abbiamo avuto la fortuna/sfortuna di nascere in una delle sue province d’oltremare potevamo guardare solo con invidia e ammirazione. Un posto da cui dipendono mode e stili di vita, in cui tutto viene deciso, dove si forgia l’idea stessa di futuro. Ecco, almeno quest’ultima parte era per la verità venuta già un po’ meno durante la doppia Amministrazione Bush, ma nemmeno in quei difficili anni di dura guerra al terrorismo era mai venuta meno la convinzione che un paese così, benché diviso e ferito, sarebbe stato per sempre.
Solo nelle storie di fantascienza degli anni ’70 (il discusso Dr. Adder di K. W. Jeter e in parte anche il successivo Noir, il racconto d’esordio di William Gibson Frammenti di una rosa olografica) o in piccole produzioni molto decentrate rispetto alla produzione mainstream (il film per la televisione La seconda guerra civile americana di Joe Dante) poteva capitare di imbattersi in scenari fantapolitici in cui gli USA si erano disuniti in un arcipelago di stati ostili all’autorità centrale, e più o meno impegnati in uno schema di rivalità reciproche sulla falsariga dell’Italia pre-risorgimentale. Se si trascurano le ucronie in cui gli Stati Confederati sono usciti vincitori o in qualche modo sono sopravvissuti alla guerra di secessione, casi concreti se ne contavano anche prima, ma tutti in qualche modo riconducibili a un qualche tipo di catastrofe (spesso connessa al tragico epilogo di una guerra nucleare) da cui emergeva un nuovo ordine in grado di mettere insieme una parvenza di governo sulle rovine del passato (penso ai classici degli anni ’60 Un cantico per Leibowitz di Walter M. Miller o a Davy, l’eretico di Edgar Pangborn).
Molti esempi sono ripresi dal sempre enciclopedico Paul Di Filippo in questo suo excursus sui futuri frammentati della fantascienza, e qualcosa avevo messo insieme anch’io in questo vecchio pezzo sulla fine del mondo. Ma credo proprio – anche se potrei sbagliare – che sia solo con i primi vagiti del cyberpunk che, sul modello della più grandiosa e inquietante delle storie alternative, quella immaginata da Philip K. Dick per La svastica sul sole, cominciano a prendere forma scenari meno granitici, che si confrontano con la prospettiva di un’America frammentata, balcanizzata dalle spinte centrifughe delle stesse entità a livello statale che la compongono. Non più una federazione, ma un continente in perenne stato di guerra intestina, bruciato da un fuoco in grado di incendiare il mondo.
Dallo scorso 6 gennaio 2021 e dal tragico assalto a Capitol Hill, è uno scenario più attuale che mai. Da osservatore remoto delle vicende americane, non mi sembra che un anno di presidenza Biden abbia potuto curare le ferite di quattro anni di trumpismo rampante, né a spazzare via le bugie sparse a piene mani dalla propaganda repubblicana negli ultimi quattordici mesi, e un editoriale del New York Times addita ora la minaccia di una spada di Damocle sospesa sulla testa della democrazia americana, che da un anno vive di fatto in un 6 gennaio permanente. È notte fonda e probabilmente questo senso di precarietà ha già scavato a fondo dentro di noi, come un fiume carsico nelle viscere del nostro immaginario di cui lo sguardo compassionevole verso il passato è solo l’ennesimo sintomo, in un lento processo durato anni che ha gradualmente, progressivamente e inesorabilmente eroso la nostra capacità di guardare al domani, saldandosi con le dinamiche di cui scrivevo a proposito della nostalgia del futuro.
Siccome è un argomento che mi sta a cuore, riprendo il discorso cominciato ieri. Dicevamo dello stato di sospensione in cui siamo in qualche modo intrappolati, autocondannati a rivivere gli stessi decenni a ciclo continuo: gli anni in cui eravamo più giovani, in cui avevamo sicuramente meno preoccupazioni, in cui ci sembrava scontato che il futuro fosse per sua natura imprevedibile e chissà quali meraviglie e/o incubi ci avrebbe portato. Col senno di poi, sembra passata una vita da quell’epoca, al punto che risulta perfino difficile stabilire se l’abbiamo vissuta davvero o se non l’abbiamo invece soltanto sognata.
In realtà, solo tre anni fa scrivevo questo pezzo, in cui nello scenario comunque fosco che lo partoriva (il fardello della sterile egemonia trumpiana sull’agenda planetaria, la Brexit all’orizzonte, etc.) riusciva comunque a mostrare un sussulto di speranza, crogiolandosi nella convinzione molto autoreferenziale che le distopie immaginate nel presente servissero in qualche modo a disinnescare le distopie a cui avrebbe potuto condannarci il futuro.
Quanta ingenuità in quelle parole, quanto inopinato ottimismo…
Eppure, non è tutto da buttare ciò che scrivevo in quell’intervento. Il discorso sulle conseguenze è proprio il succo di tutta la storia. In fondo, se siamo sempre più disposti a nutrirci e a vivere di nostalgia, è perché abbiamo smarrito il senso del futuro, perdendolo per strada o facendocelo rubare da chi ha tutto l’interesse a protrarre lo status quo, e che mai come nell’epoca in cui viviamo si ritrova a disposizione una varietà di strumenti ideologici e tecnologici di impareggiabile efficacia per perseguire i propri fini. Armi di distrazione di massa, le chiamavamo tempo fa.
A cambiare la prospettiva rispetto a tre anni fa, c’è stata ovviamente la prima vera crisi globale che le ultime tre generazioni si siano trovata a vivere sulla loro pelle: il convitato di pietra di questo discorso, lo avrete capito, è il grande innominabile attuale, l’evento che per la prima volta ci ha messi di fronte alla nostra fragilità come specie, la pandemia da COVID-19. E qui ci tengo a specificare bene a cosa mi riferisco, per non essere facilmente frainteso: più che alla malattia in sé, che è comunque una bestia contro cui adottare tutte le contromisure possibili, a smascherare la natura illusoria delle mie – delle nostre – proiezioni è stata la nostra gestione della crisi. Una gestione lacunosa, largamente deficitaria, astrusa e a tratti inspiegabile, se non insensata tout court, da parte delle autorità preposte: la fantomatica Organizzazione Mondiale della Sanità e i governi nazionali, tanto quelli negazionisti di USA, Brasile e fino a un certo punto UK, quanto quelli più prudenti come buona parte dell’Europa. Ma anche una applicazione schizofrenica, caotica, confusionaria, autolesionista, contraddittoria, egoistica, da parte dei cittadini, che mai come in uno stato di emergenza come questo avrebbero dovuto essere guidati verso la soluzione migliore per tutti, e invece sono stati lasciati in balia delle loro paure, idiosincrasie, superstizioni… e chi più ne ha più ne metta.
Il risultato è che lo stato interliminale in cui sembravamo aver messo piede alla fine della primavera 2020 si è dilatato a dismisura. A misurare l’entità di questo abisso in cui stiamo sprofondando, possono venirci in soccorso ancora una volta i numeri: un anno e mezzo fa, quando cominciavamo a intravedere una fioca luce in fondo al tunnel, non eravamo ancora arrivati a dieci milioni di casi nel mondo e le vittime accertate erano meno di mezzo milione; oggi, la spietata contabilità di Worldometers ci informa che il virus ha infettato 282 milioni di persone, portandosene via più di cinque milioni.
E se questa è stata la gestione di una crisi di cui da subito si era compresa la rilevanza, non serve questo grande sforzo di immaginazione per ipotizzare come andrà a finire con il vero evento che ci sovrasta tutti dall’alto della sua ampiezza come rischio esistenziale: la Sesta Estinzione, di cui il fattore più in vista è sotto gli occhi di tutti nella forma non più trascurabile della crisi climatica in atto. Cercare qualcos’altro da guardare, mentre il mondo va a picco nello scarico cosmico, è un modo di affrontare il problema tutto sommato coerente e in linea con l’atteggiamento tenuto da tutti, istituzioni, autorità e persone comuni, durante la pandemia. C’è una certa poesia perfino nel modo in cui rende giustizia a un evento che di fatto ha tracciato una linea tra ciò che potevamo solo immaginare prima, e ciò che invece saremo costretti a vivere dopo.
Sull’ultimo numero di Narrativa, uscito nei giorni scorsi, è presente un dettagliato, puntuale, come al solito documentatissimo e attento intervento di Arielle Saiber sul connettivismo, che comprende anche una lunga intervista al sottoscritto.
Narrativa è una rivista dedicata alla letteratura italiana contemporanea, fondata nel 1992 e pubblicata dalle Presses universitaires de Paris Nanterre. La nuova serie, lanciata nel 2006 e diretta da Silvia Contarini, come si legge dal sito “propone a scadenza annuale saggi e recensioni sulla produzione letteraria più recente, privilegiando una costante riflessione sul rapporto che intercorre tra creazione, immaginario, pensiero, e il tempo presente, l’evento, l’attuale”, “con la convinzione che la letteratura è anche uno stumento di conoscenza e di comprensione delle trasformazioni in corso, sia nel mondo che nell’essere umano”.
Ho avuto modo di dare una sbirciatina al volume in anteprima e sono rimasto impressionato dal saggio di Marco Malvestio, autore anche del recente Raccontare la fine del mondo. Fantascienza e Antropocene per Nottetempo, e che nel suo intervento (Sognando la catastrofe. L’eco-distopia italiana del ventunesimo secolo) conferma un’attenzione per la produzione di genere, anche la meno appariscente e sbandierata dagli editori con etichette improbabili (il classico “non è semplice fantascienza” piuttosto che “trascende la fantascienza”, u.s.w.), che per una volta conforta il senso comune dell’appassionato di fantascienza, e in particolare della fantascienza viva e in continua mutazione degli ultimi vent’anni, non solo quella ormai in gran parte fossile del Novecento. In linea con l’approccio di questo numero, che “nasce dalla definizione della fantascienza italiana come un genere «aperto», all’interno del quale coabitano sottogeneri quali le narrazioni distopiche e eco-distopiche, l’ucronia, i testi post-catastrofisti, e capace di rappresentare le problematiche più attuali della società”.
Purtroppo sia il pezzo di Malvestio che l’intervista che mi ha fatto Arielle risulteranno disponibili on line solo più avanti nel 2022. Ma questo intanto è l’abstract che mi riguarda:
Nel contesto della fantascienza italiana, il connettivismo, in parte seguendo le suggestioni del cyberpunk, ha cercato di mettere in relazioni suggestioni scientifiche e sperimentazioni letterarie. Nell’articolo-intervista, l’autrice ne rintraccia il percorso cronologico e le principali influenze culturali con uno dei più importanti protagonisti.
Mentre questa che segue è la presentazione che ne fanno i curatori Daniele Comberiati e Luca Somigli nella loro introduzione:
Una vocazione transmediale caratterizza anche il progetto del movimento connettivista, di cui dà conto Arielle Saiber in un’ampia intervista a uno dei suoi fondatori, Giovanni De Matteo, preceduta da una nota critica e di poetica. Se il termine “connettivismo” è di derivazione letteraria e rimanda a un autore della fantascienza classica, A. E. van Vogt, la sua ripresa in questo contesto vuole evocare invece quell’incrocio di forme di sapere e di produzione culturale il cui potenziale è stato moltiplicato dalle nuove piattaforme mediatiche, internet prima su tutte. L’intersezionalità è dunque insita nel nome del movimento stesso, teso alla ricerca, come scrive Saiber, di “un tentativo di sintesi e ibridazione: tra linguaggi e forme espressive diverse, tra mondi in opposizione e saperi sbrigativamente considerati inconciliabili, tra generi reputati statici e cristallizzati”. Nel ripercorrere la storia del movimento dal lancio del manifesto fondativo nel 2004, Saiber ne sottolinea la capacità aggregativa intorno a case editrici e progetti online, in un continuo processo di sperimentazione che, pur tenendo la letteratura al suo centro, spazia dalle arti figurative alla musica.
L’antologia è lì fuori da poco più di tre mesi e mi rendo conto di non averne ancora parlato. Quindi direi che è arrivato il momento di rimediare.
La sindrome di Kessler e altri racconti è un campionario della mia scrittura dal 2004 al 2020. Mancano una manciata di titoli che mi sarebbe piaciuto includere, ma o per questione di diritti (è il caso di Al servizio di un oscuro potere, uscito lo scorso anno sul Millemondi dedicato alla distopia), o per la prospettiva di progetti antologici a tema (La vita nel tempo delle ombre, Orizzonte degli eventi e Vanishing Point), o per entrambe le ragioni (Maja, Il lungo ritorno di Grigorij Volkolak, Sulle ali della notte), sono rimaste fuori da questa raccolta. Per il resto, il volume, che include 28 racconti e conta la bellezza di 490 pagine, offre tutto il meglio di quello che mi è riuscito di scrivere in questo intervallo di tempo, dopo i primi timidi tentativi del 2003, e prima dell’ultimo anno che vedrà comunque uscire almeno una novità da qui a fine mese.
Il lettore più attento ci troverà molte storie che probabilmente già conosce, in particolare i racconti vincitori di premi (Viaggio ai confini della notte e Red Dust), i racconti ospitati da Robot (Cloudbuster) o Next/Next-Station (SIN: Stati Indotti di Narcolessia) o i microracconti usciti in precedenza sul blog (Novilunio, Orfani del cielo, Civiltà di prova), ma tutti sono passati sotto le amorevoli cure dell’accetta dell’editor, ed essendo trascorsi in alcuni casi più di quindici anni dalla loro precedente apparizione l’intervento è stato tutt’altro che indolore. Per tutti, ci saranno comunque delle sorprese, a cominciare da un inedito assoluto (Ruggine), sviluppato come tassello di un più ampio progetto steampunk su un’Italia fin de siècle alternativa che purtroppo, per varie vicissitudini editoriali, non ha mai visto la luce.
Organizzate tematicamente in sezioni, queste storie esplorano la frontiera tra connettivismo e cyberpunk (Connessioni) o tra postumanesimo ed esplorazione spaziale (Transizioni), oppure si addentrano in diversi filoni della letteratura di fantascienza, dall’ucronia al viaggio nel tempo al New Weird (Deviazioni), dalla discronia alla letteratura ricorsiva (Mutazioni). Completano il volume cinque racconti-bonsai che si spingono ai limiti del conte philosophique (Iterazioni). Insomma, rappresentano uno spaccato davvero eterogeneo rappresentativo credo non solo della mia scrittura, ma più in generale delle molteplici anime che convivono in questo calderone così difficile da definire che tutti sappiamo essere la fantascienza.
Anche per questo motivo, ogni racconto è preceduto da un’introduzione scritta ad hoc per inquadrarne il background: ho voluto in questo modo omaggiare i miei maestri e le mie fonti di ispirazione, e inoltre fornire ai lettori nuove coordinate per tracciare eventuali nuovi percorsi di lettura, che spesso finiscono per sconfinare fuori dal genere.
Il libro è uscito per Kipple Officina Libraria con una prefazione di Linda De Santi. La copertina è di Franco Brambilla. Se avete altre domande, lo spazio dei commenti è a vostra disposizione.
Seconda segnalazione robotica in meno di una settimana, per annunciarvi che è uscito il numero 90 della leggendaria rivista di fantascienza fondata da Vittorio Curtoni e attualmente diretta da Silvio Sosio, e che tra le sue pagine ha trovato in extremis confortevole asilo anche il mio articolo-moloch sullo sviluppo semiotico dell’utopia. Perché se è vero che il blog è impermanente per definizione, come tutto quello che è codificato in pacchetti di bit in un server oceanico da qualche parte, le pagine di Robot sono per sempre.
Un sole di gomma fu squassato, e tramontò; e un nulla nero-sangue si mise a far girare un sistema di cellule intrecciate con cellule intrecciate con cellule intrecciate dentro un unico stelo. E spaventosamente nitida, sullo sfondo di tenebra, una candida fonte zampillò.
Vladimir Nabokov, Fuoco pallido, traduzione di Franca Pece e Anna Raffetto per l’edizione italiana Adelphi (2002)
Finalmente la mia copia del balenottero è venuta a spiaggiarsi qui di fianco e quindi quale occasione migliore per parlarvi un po’ del mio racconto? Il senso del post, come avrete capito, è quanto di più autoreferenziale si possa immaginare. Se decidete di andare avanti, sapete cosa aspettarvi.
1. Riferimenti letterari
Come fa giustamente notare il curatore del volume Franco Forte (che ringrazio oltre che per aver messo in luce il modello, anche per avermi dato la possibilità di comparire ancora una volta in un libro con diverse autrici e autori per cui non ho mai fatto mistero di nutrire da lettore – e a volte anche, nel mio piccolo, da curatore – un apprezzamento incondizionato), sul mio racconto aleggia l’ombra di Sergio “Alan D.” Altieri. Alla fine i conti tornano, no?
Anche lui forse avrebbe usato per questo racconto l’etichetta sci-fi action, che non so se merito, però mi avrebbe fatto senz’altro piacere.
Accanto a lui, altri riferimenti al mio personale pantheon letterario che fanno capolino tra le pagine sono meno scontati per un racconto di fantascienza quale Al servizio di un oscuro potere è, e in particolare penso a H. P. Lovecraft, Thomas Ligotti e Breece D’J Pancake.
2. Suggestioni e ispirazioni
Lo spunto di partenza, la scintilla che ha innescato la suggestione da cui è scaturito il racconto, è una sequenza di fotogrammi di Bologna, una mattina presto d’inverno di due o tre anni fa. In superficie la città deserta, spazzata da un vento gelido che strappava pioggia ghiacciata a un cielo di marmo. Nel sottosuolo, il labirinto multi-livello della stazione dell’alta velocità, con le sue lunghe passerelle di vetro sospese sui binari e immerse in un’atmosfera ovattata, altrettanto rarefatta, e le voci dei passeggeri in attesa che si perdono in lontananza, soffocate dai volumi delle navate sotterranee.
La cordiale voce registrata del sistema di annunci sonori diffusi dagli altoparlanti è stata da ispirazione per Mezereth. Con la complicità di un umore appena più torvo del solito, non è stato difficile delineare invece il personaggio di Maksim Bogdanov. Il nome è un omaggio ad Aleksandr Bogdanov, sulla cui figura è incentrato Proletkult dei Wu Ming, ma anche ad Arkady Bogdanov, uno dei personaggi più intriganti della Trilogia Marziana di Kim Stanley Robinson.
3. Storie dentro storie dentro altre storie
Keira è antecedente a entrambi, essendo ormai anni che medito di raccontarne la storia. Una storia che inizia in una città devastata dalla guerra, subito dopo il crollo della civiltà, e si conclude a bordo di un’astronave interstellare che si lascia alle spalle un sistema solare irreversibilmente sconvolto. In mezzo ci sono un annuncio del SETI a lungo atteso, ma che forse mai avremmo voluto sentirci dare sul serio, e il Programma Majestic. Di tutto questo si fa menzione in Al servizio di un oscuro potere, che va così a coprire con una prima tessera il mosaico di una storia più ampia e più antica. Il resto, prima o poi, lo scriverò.
Dimenticavo. Il personaggio che fa da contraltare a Maksim nella ricerca di Keira per conto di Mezereth si chiama… Irene Adler. Ovviamente, non quella Irene Adler.
4. World-building
Nel mondo post-apocalittico in cui vivono Maksim e Irene Adler, la società e le sue strutture di potere sono state commissariate dalle intelligenze artificiali. Amorevoli, altruistiche IA come Mezereth hanno preso in custodia il genere umano per il bene della civiltà. E gli umani, per lo meno quelli sopravvissuti all’ultima guerra totale, sono stati incasellati, per il loro bene, in ruoli predefiniti in virtù della loro classificazione in sedici tipi psicologici, che riprende lo schema messo a punto dalle psicologhe Myers e Briggs, per altro madre (la seconda) e figlia (la prima), nel secondo dopoguerra (per scoprire il vostro tipo MBTI, potete sottoporvi a test più o meno accurati, anche on line se ne trovano di diversi, tra cui questo in italiano).
Nel racconto mi diverto a giocare, come si sarà capito poco sopra, con i rischi esistenziali di Nick Bostrom, provando ad azzardare una risoluzione “artificiale” del dilemma del prigioniero, che porta a pagare un prezzo alto ma accettabile per evitare la distruzione assicurata. Questo dilemma, nel racconto, è legato al paradosso di Fermi, e a una possibile spiegazione che è stata già affrontata con eccellenti risultati da autori come Stephen Baxter, Alastair Reynolds e Liu Cixin.
5. Altri mondi, altre storie
Il nome della città in cui si apre e finisce il racconto, al-Hastur, è una citazione abbastanza trasparente di Robert W. Chambers, i cui racconti del ciclo del Re in Giallo sono andati a costituire il nucleo di un universo letterario di rimandi e citazioni che si è avvalso nel corso del tempo dei contributi, tra gli altri, di H. P. Lovecraft, sublimando nell’immaginario popolare anche grazie al lavoro di Nic Pizzolatto sulla prima stagione di True Detective.
In effetti, con tutti questi link, sembra che non abbia dovuto fare altro che mettere un po’ di ordine nella cronologia del blog. Ma è stato un po’ più complessa di così.
Nella descrizione di al-Hastur come di una città mausoleo, uno spettrale sepolcro imbiancato, riverberano le sensazioni di Cuore di tenebra di Joseph Conrad, in cui si ritrova una descrizione di Bruxelles che gli permette di materializzare una critica all’imperialismo colonialista europeo (“Mi ritrovai nella città sepolcrale risentito alla vista di individui che si affrettavano nelle strade per sgraffignare un po’ di denaro l’uno all’altro, […] per sognare i loro sogni sciocchi e insignificanti. Calpestavano i miei pensieri. Erano intrusi e la conoscenza che avevano della vita mi appariva un’irritante finzione, perché mi sentivo così sicuro che non potessero certo sapere le cose che sapevo io“).
Ho aggiunto il prefisso al un po’ per un tocco di esotismo, un po’ per caricarlo di un vezzo demoniaco, e poi perché mi sono detto: con tutti questi riferimenti, perché non citare anche Jack Vance?
6. E il titolo?
Ok, adesso l’ultima e poi evito di importunarvi oltre. Il titolo, vi starete chiedendo, o forse no, ma ormai avrete capito che ho comunque intenzione di dirvelo.
Al servizio di uno strano potere è il titolo, preso in prestito da uno dei suoi racconti, di un’antologia di Samuel R. Delany pubblicata in Italia in un numero monografico di Robot (il 35, per l’esattezza, nel febbraio del 1979). Robot è la mia rivista preferita, Delany è uno degli autori di cui non potrei fare a meno (e tra i primi che citerei se mi venisse chiesto il nome di uno scrittore che tutti dovrebbero conoscere) e questa antologia è uno scrigno di pietre preziose (così parafrasiamo pure il suo titolo più bello).
Al servizio di un oscuro potere esiste anche grazie a Robot e a Delany. Ed è un’influenza che va al di là del titolo, ma che il titolo mette da subito in chiaro.
Buona lettura!
E così ci siamo. L’attesa è finita. Preceduto dal libro evento del 2019 (asso pigliatutto all’ultima edizione del Premio Italia), annunciato in pompa magna, accompagnato da una campagna promozionale come raramente se ne vedono in Italia quando si parla di fantascienza (e chissà perché ancor più quando si tratta di fantascienza italiana… se non quando la fantascienza è il pretesto per allenare la consolidata virtù italica del velleitarismo coloniale), è il momento del Millemondi dell’estate 2020: Distòpia.
Curata ancora una volta da Franco Forte, impreziosita come sempre da una cover memorabile di Franco Brambilla e completata da una postfazione di Carmine Treanni sulla strana attrazione che esercita “il peggiore dei mondi possibili”, l’antologia dedicata alla fantascienza scritta da autori italiani si è concentrata questa volta su un tema che, all’origine, nessuno si sarebbe di certo aspettato sarebbe stato così d’attualità al momento dell’uscita in edicola: fin dal titolo, che rifugge qualsiasi tentazione di camuffamento, a fare la parte del leone saranno i futuri avversi, i mondi allo sfascio, le società totalitarie, le piccole e grandi distorsioni – o, se preferite, perversioni – di cui l’umanità sa rendersi capace.
Dalla presentazione del volume:
Tenetevi pronti a sognare agli scenari immaginati da alcuni dei migliori scrittori della fantascienza italiana, riuniti da Franco Forte, curatore dell’antologia.
Le loro visioni vi porteranno a incontrare un androide nelle gelide miniere di Plutone, a indagare insieme a una Nativa Mentale i segreti di un’Italia virtuale (o meglio “n’Italia”) post pandemia, ad aggirarvi sotto i tramonti oscuri della città di Morjegrad, preda di strani blackout.
Preparatevi a danzare con un’umanità mutilata dall’editing genetico, a inseguire ali di farfalla in un mondo prosciugato dalla vita, a far crepitare di raggi laser la neve grigia dell’inverno nucleare.
Tra le pagine di “Distòpia” scalerete i durissimi canoni estetici del riallineamento, sarete assordati dal frastuono del crollo dei grandi monumenti della Terra, andrete a caccia di emozioni forti in un mondo che ha sacrificato la privacy e il contatto umano a favore di un’inquieta sicurezza, andrete a caccia all’ispirazione insieme a uno scrittore disperato.
Potrete farvi inebriare dal fascino digitare di un/a Perfect Companion, colonizzare un pianeta meticcio e multispecie e persino perdervi in un futuro psichedelico governato da hashtag e captcha.
Per quanto mi riguarda, Distòpia giunge dopo Cronache dell’Armageddon e Lo Zar non è morto e completa un trittico che per puro caso, dopo una lavorazione di diversi mesi, è arrivato a convergere su questo scorcio di estate post-pandemica, suggellando un mese di giugno di rara produttività.
Magari del mio racconto parleremo nei prossimi giorni. Intanto, ci vediamo in edicola!
L’interliminale, quello spazio situato tra due soglie, che non appartiene né allo spazio prima né a quello dopo, è un concetto che somiglia molto alla condizione che stiamo vivendo da alcune settimane. Decretata a inizio maggio la fine del lockdown, siamo entrati in questo «spazio di mezzo», in cui non siamo più ibernati né pienamente tornati alla libertà di prima. Viviamo quindi in una condizione sospesa, in cui non solo quello che continua a succedere intorno a noi, ma anche quello che ci si profila davanti allunga ombre ancora piuttosto fosche sul nostro presente.
Nel mondo si sono superati oggi i 7,5 milioni di casi, le vittime sono oltre 420.000, e il contagio ha non solo raggiunto dimensioni preoccupanti in Brasile e Russia, ma cresce rapidamente in paesi come Perù, Cile, Messico, Pakistan, Bangladesh e Sud Africa, tutti caratterizzati da aree urbane densamente abitate, in cui il distanziamento sociale si sta dimostrando di difficile attuazione in assenza di rigide disposizioni di contenimento. Ormai ci stiamo gradualmente abituando all’idea di dover convivere a lungo con il virus.
In questo scenario, sono venuti meno molti dei miei propositi degli ultimi mesi, inclusa la voglia di aggiornare regolarmente il blog, che invece per alcune settimane ero riuscito a trovare. Ma nell’Interliminale tutto si fa tranne crogiolarsi nell’inattività. E in effetti, dietro le quinte, sono state settimane frenetiche, in cui sono culminati alcuni progetti che da mesi (e in alcuni casi anche anni) erano in gestazione.
Di alcuni di questi vi parlerò nei prossimi giorni (in effetti se ne sta già parlando, nei corridoi della rete). Per altri, l’auspicio è che la gestazione porti prima o poi a dei risultati pubblicamente spendibili.









































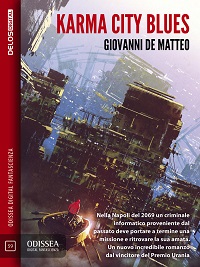


Interazioni recenti