You are currently browsing the tag archive for the ‘simulacri’ tag.

Di cosa parliamo quando parliamo di cyberpunk? La risposta è molto meno scontata di quanto potrebbe sembrare a un approccio superficiale. Il cyberpunk letterario è stato spesso accusato di scarsa originalità, monotonia di fondo e, col tempo, conformismo a tutta una serie di elementi divenuti un po’ dei cliché: il mondo distopico dominato dalle multinazionali, gli hacker solitari in lotta contro il sistema, la vita di strada nei bassifondi delle megalopoli… e potremmo continuare. Ma se prendiamo in considerazione i due titoli che hanno contribuito maggiormente a plasmare la nuova sensibilità della fantascienza dagli anni ’80 in avanti, ci accorgiamo di tutta una serie di differenze anche abissali legate non a elementi di contorno, che tutto sommato sono anche abbastanza sovrapponibili (*) – come dimostrano anche le dichiarazioni di William Gibson sulla sua esperienza come spettatore in sala all’uscita di Blade Runner – ma su un elemento che per il cyberpunk è tutto fuorché accessorio: la tecnologia.
(*) E che così di contorno, come vedremo tra poco, comunque non sono.
La tecnologia in Neuromante
Partiamo da Neuromante, il manifesto letterario del cyberpunk. Uscito nel 1984, è ambientato secondo le stime di Gibson intorno al 2035 (sebbene l’arco della trilogia copra 16 anni e quindi questa datazione vada presa molto con le molle, potendo oscillare, diciamo, tra il 2025 e il 2040… ma tutto sommato ancora dietro l’angolo, a differenza di quanto dedotto invece da un lettore su Vice basandosi su altri elementi interni ai romanzi ma probabilmente più dovuti a sviste dell’autore che non riconducibili alle sue reali intenzioni) e dipinge una tecnologia ormai smaterializzata, micro- e nanometrica, pervasiva.
Nel mondo di Case e Molly, la tecnologia si è ormai integrata in maniera indistricabile con i corpi e la psiche degli utenti: il cyberspazio è un piano dell’esistenza complementare alla realtà fisica, con cui si compenetra in declinazioni che assumono di volta in volta le forme di un’internet ante litteram, della realtà virtuale o di una realtà aumentata, e che assolve al ruolo di vero e proprio ecosistema, con le sue nicchie e i suoi agenti (virus informatici, ICE, costrutti di personalità riconducibili al mind uploading, intelligenze artificiali…).
Case, Molly e gli altri abitanti del futuro come loro non esitano a modificare i propri corpi attraverso impianti prostetici che ne aumentano le facoltà e attivano un feedback con il cyberspazio: non sono più solo agenti, ma la loro psiche e il loro organismo diventa un target su cui la rete e altri agenti possono produrre effetti tangibili. La strada ha trovato il suo uso per la tecnologia uscita dai laboratori, per dirla con Gibson. Anzi, ha trovato mille modi per utilizzarla e piegarla alle necessità dei singoli operatori, attraverso tutto un mercato nero di tecnologie trafugate dai centri di ricerca delle multinazionali o dell’esercito e messe in circolazione da una rete di contrabbandieri, corrieri, rigattieri…
La tecnologia in Blade Runner
La visione della Trilogia dello Sprawl prende forma tra la fine degli anni ’70 e i primissimi ’80, e nel 1982 arriva nelle sale Blade Runner. Un film che si inserisce nel solco di quella visione cupa e pessimistica del futuro che negli stesi anni si andava definendo grazie a pellicole epocali come Mad Max di George Miller (1979) e 1997: Fuga da New York di John Carpenter (1981), o Alien dello stesso Ridley Scott (1979). Ma, con la notevole eccezione di quest’ultimo, i film che stavano ridefinendo l’immaginario del futuro erano prevalentemente accomunati da un basso tasso tecnologico: la tecnologia era o ridotta al puro elemento meccanico (le automobili di Mad Max con cui vivono in simbiosi i sopravvissuti dell’outback australiano) o a strumento di controllo (le bombe miniaturizzate iniettate a Plissken per convincerlo a esfiltrare il presidente dal carcere di massima sicurezza di Manhattan).
Lo stesso Alien non è che brilli sotto il profilo dell’estrapolazione tecnologica, ma se non altro, sullo sfondo di una civiltà che è stata comunque in grado di mettere in campo lo sforzo necessario a esplorare rotte spaziali al di fuori del sistema solare, presenta personaggi che sono androidi meccanici indistinguibili dagli esseri umani e computer che rasentano, per autorità anche se non proprio per flessibilità (e qui torniamo alle forme di controllo già citate sopra a proposito di 1997: Fuga da New York), lo status delle IA. Elementi che, con le dovute variazioni, caratterizzano anche Blade Runner, dove ritroviamo appunto una tecnologia pesante: gli avanzamenti nella biotecnologia hanno permesso lo sviluppo di replicanti, androidi biologici indistinguibili dagli esseri umani (anzi, più umani dell’umano), destinati all’impiego in teatri di guerra extra-mondo e a farsi carico di mansioni che richiedono forza e resistenza fisica. L’uso più soft contemplato per i Nexus-6, i replicanti di ultima generazione, è per i modelli femminili, adibiti alla prostituzione nei bordelli delle colonie, non proprio un esempio di visione futuristica sull’impiego del più sofisticato prodotto della tecnologia umana.
In Blade Runner, la tecnologia è sempre separata dai corpi e dalle menti dei suoi utilizzatori umani: l’intermediazione tecnologica nelle relazioni umane è ridotta al minimo, i telefoni sono ancora in cabine pubbliche, i computer quasi nemmeno si vedono e – tralasciando volutamente, per il momento, qualsiasi grande o piccola retcon operata da Blade Runner 2049 – la rete nemmeno esiste. La tecnologia non è bassa, ma è sostanzialmente hard e ha a che fare con la programmazione/manipolazione biologica dei corpi, confinata all’interno di questi (alcune decine o centinaia di migliaia di replicanti sparsi sulle colonie extra-mondo, e pochissimi fuggitivi clandestini sulla Terra), mentre il mondo di fuori è sostanzialmente la fucina di catastrofi ambientali in cui ci troviamo a vivere oggi, con un downgrade della tecnologia attuale a quella degli anni ’80.
Blade Runner & Neuromancer: convergenze non accidentali
Per inciso, ricollegandoci a quanto dicevamo in apertura sulla sovrapponibilità degli elementi d’ambiente e le atmosfere, è interessante anche notare come Gibson e Scott condividessero una visione sostanzialmente comune su quella che l’autore di Neuromante definisce “la più caratteristica delle nostre tecnologie“: la città. Entrambi, Gibson sulla pagina scritta e Scott nei set di Blade Runner, compiono un’operazione che potrebbe apparire scontata (soprattutto a un europeo, sostiene Gibson): sovrapporre elementi del passato, del presente e del futuro nella rappresentazione delle città. In pratica: dare evidenza della stratificazione delle epoche attraverso il mélange architettonico che plasma l’estetica della città.
Ciò che Ridley Scott fa con Blade Runner, lo si ritrova nella stessa misura sia in Neuromante che nei precedenti racconti di Gibson: le strade delle loro città sono concentrati di archeologia urbana e per questo danno una misura incontestabile del tempo che è corso su quelle superfici e di ciò che è costato.
Blade Runner vs Neuromancer: dove saltano gli schemi
Tutto semplice, quindi? Forse no, perché il doppio finale di Blade Runner, con il problema della duplice interpretazione della natura di Deckard, complica significativamente lo schema fin qui delineato. A seconda delle letture che si vogliono dare al personaggio, il cacciatore di replicanti può essere un umano (chiave interpretativa prediletta dall’interprete del ruolo Harrison Ford) o un replicante lui stesso (lettura sostenuta a più riprese da Ridley Scott, almeno fino all’uscita nelle sale del sequel di Denis Villeneuve che invece opta per la versione di Ford).
Se Deckard è un umano, la sua fuga finale con Rachael assume le valenze metaforiche di un matrimonio tra la sfera umana e quella artificiale, una sorta di romantica conciliazione tra la natura e la tecnologia. Poco plausibile forse, sicuramente suggestiva, estrinsecata in particolare nella sequenza dell’auto che attraversa i boschi a nord di Los Angeles sulle note incalzanti della leggendaria colonna sonora di Vangelis. Si tratta del finale voluto dallo sceneggiatore Hampton Fancher e realizzato da Scott su input della produzione “riciclando” le sequenze girate per Shining scartate da Stanley Kubrick.
Se Deckard al contrario è un replicante, la sua scoperta finale (molto in linea con la sensibilità di Philip K. Dick benché non fedele alla lettera al romanzo), suggellata dalla chiusura delle porte dell’ascensore scelta come final cut dal regista, diventa l’agnizione lacerante dell’incompatibilità della propria esistenza con la natura, l’anamnesi sul proprio essere – esattamente come i replicanti a cui il cacciatore ha finora dato la caccia – una contraddizione in atto, la prova «vivente» che la realtà ha ormai raggiunto un livello di falsificazione da cui è impossibile tornare indietro: non sono solo i ricordi a essere contraffatti, ma l’effetto si estende inevitabilmente alla percezione stessa della realtà. La natura è destinata a scomparire, sostituita da repliche che si credono originali e reali. Le superiori capacità mimetiche dei simulacri renderanno infine vano qualsiasi tentativo di resistenza.
La versione di Ford (e di Fancher) chiude in qualche modo un cortocircuito con la visione tecnologica di Neuromante, dove la sintesi tra organico e sintetico viene subita ma a cui non ci si sforza di resistere, cercando piuttosto di piegarla alle esigenze dei protagonisti: sotto questa luce, Blade Runner prospetta un’accettazione perfino ottimistica di questa sintesi, facendo quindi un ulteriore passo avanti.
La versione di Scott (e di Dick), invece, stabilisce che non c’è ragione di sposare ciò che è fuori con ciò che è dentro, l’organico e l’inorganico. Semplicemente, l’inorganico, l’artificiale, il sintetico, il simulacro, ormai più umano dell’umano, è destinato a soppiantare l’organico, il naturale, l’originale. Non c’è scampo, non esiste via di fuga, la partita è segnata.
Siamo sotto scacco, a una mossa di distanza dallo scacco matto. Solo che non ce ne siamo ancora resi conto.
 Roy Batty, nell’interpretazione artistica di Christopher Shy.
Roy Batty, nell’interpretazione artistica di Christopher Shy.Non è molto sportivo sparare su un avversario disarmato. Io pensavo che tu dovessi essere bravo. Non eri tu quello bravo? Vieni Deckard. Fammi vedere di cosa sei fatto.
È a un crudele scherzo del destino che tutti avremo pensato apprendendo la scorsa estate la notizia che Rutger Hauer ci aveva lasciati dopo una breve malattia. L’uomo che aveva dato un volto e una voce a Roy Batty ci lasciava proprio nell’anno che era stato fatale al suo personaggio più memorabile. Ma la sorte si era dimostrata perversamente beffarda con Hauer ben prima del 19 luglio 2019: se si eccettua forse il magnetico Navarre in Ladyhawke di Richard Donner (1985), nessun’altra performance aveva saputo replicare il successo, la carica iconica e la persistenza nell’immaginario del suo secondo ruolo per Hollywood.
E questo benché molti di noi ne avessero apprezzato la presenza in film di seconda categoria, che proprio grazie alla sua partecipazione hanno sviluppato col tempo un alone di culto: pellicole di serie B come Giochi di morte (1989) o Detective Stone (1992) o produzioni televisive come Fatherland (1994), così come anche film se vogliamo ancor più privi di pretese come Sotto massima sorveglianza (sempre del 1989) o di categoria perfino inferiore come Arctic Blue (1993), Omega Doom (1996), Hemoglobin – Creature dell’inferno o Redline (entrambi del 1997). Pronunciate un titolo a caso tra gli oltre cento a cui ha preso parte nell’arco della sua carriera, e troverete da qualche parte un club di estimatori disposti a cantarne le lodi al di là dei limiti che sarebbero evidenti a chiunque. Chiamatelo, se volete, effetto Hauer, e sappiate che funzionava da molto prima che l’attore olandese cominciasse a capitalizzarlo in produzioni rispettate come Confessioni di una mente pericolosa di George Clooney (2002), Sin City di Robert Rodriguez e Frank Miller e Batman Begins di Christopher Nolan (2005).
a caso tra gli oltre cento a cui ha preso parte nell’arco della sua carriera, e troverete da qualche parte un club di estimatori disposti a cantarne le lodi al di là dei limiti che sarebbero evidenti a chiunque. Chiamatelo, se volete, effetto Hauer, e sappiate che funzionava da molto prima che l’attore olandese cominciasse a capitalizzarlo in produzioni rispettate come Confessioni di una mente pericolosa di George Clooney (2002), Sin City di Robert Rodriguez e Frank Miller e Batman Begins di Christopher Nolan (2005).
D’altro canto, il contributo di Rutger Hauer alla pellicola di Ridley Scott fu incommensurabile. Le sue qualità attoriali furono determinanti tanto per caratterizzare il leader dei replicanti ribelli, quanto per contribuire a renderlo una figura senza precedenti nel nostro immaginario. Anzi, mi spingerò oltre affermando che è grazie a lui se abbiamo avuto un Roy Batty diametralmente opposto alla fredda, spietata e inesorabile macchina da guerra che era il Roy Baty di Philip K. Dick. Il personaggio da cui partiva era infatti un grigio epigono della creatura del dottor Frankenstein, del tutto privo di qualsiasi afflato romantico e meno interessante di tutti gli altri androidi con cui il cacciatore a premi Deckard entra in contatto nel corso della sua battuta di caccia.
 Rutger Hauer in una scena del film Blade Runner, 1982. (Photo by Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images)
Rutger Hauer in una scena del film Blade Runner, 1982. (Photo by Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images)Nelle mani di Hauer, invece, il processo di crescita già intrapreso con il passaggio di consegne tra Hampton Fancher e David Peoples alla sceneggiatura giunge a compimento e produce un frutto forse inatteso: un personaggio che è in grado di eclissare qualunque altro personaggio con cui si trovi a condividere la scena, che si tratti del suo creatore Eldon Tyrell (che proprio tra le sue mani finisce immolato in un truculento rituale teocida) o del protagonista Rick Deckard (peraltro interpretato dall’astro nascente Harrison Ford). E Roy Batty diventa l’antagonista con cui lo  spettatore non può fare a meno di solidarizzare, l’anti-Frankenstein per eccellenza: una creatura sintetica, creata dall’uomo e superiore a esso per intelligenza, forza e resistenza fisica, ma che si spoglia di qualsiasi componente perturbante con una metamorfosi finale, rivelandosi superiore agli stessi esseri umani nell’unica facoltà che davvero dovrebbe tracciare la linea di demarcazione tra le due condizioni, ovvero l’empatia. E come se non bastasse, in virtù di questa evoluzione, in aggiunta a tutti i parallelismi con il martirio cristiano che sono fin troppo facili da individuare nel corso di Blade Runner, la ribellione dei replicanti ai loro creatori assume anche una inattesa dimensione politica, sviluppando una dialettica di chiaro stampo marxista. Emblematica a questo proposito la battuta-chiave:
spettatore non può fare a meno di solidarizzare, l’anti-Frankenstein per eccellenza: una creatura sintetica, creata dall’uomo e superiore a esso per intelligenza, forza e resistenza fisica, ma che si spoglia di qualsiasi componente perturbante con una metamorfosi finale, rivelandosi superiore agli stessi esseri umani nell’unica facoltà che davvero dovrebbe tracciare la linea di demarcazione tra le due condizioni, ovvero l’empatia. E come se non bastasse, in virtù di questa evoluzione, in aggiunta a tutti i parallelismi con il martirio cristiano che sono fin troppo facili da individuare nel corso di Blade Runner, la ribellione dei replicanti ai loro creatori assume anche una inattesa dimensione politica, sviluppando una dialettica di chiaro stampo marxista. Emblematica a questo proposito la battuta-chiave:
Bella esperienza vivere nel terrore, vero? In questo consiste essere uno schiavo.
Roy Batty è stato davvero il primo esemplare di una nuova umanità, o se volete della postumanità, sul grande schermo. La migliore tra le creature artificiali ma “più umane dell’umano” che si fa paladina di un ideale di giustizia e libertà, e che si mostra davvero più umana degli esseri umani al culmine di un percorso che ha scavato nel cuore di tenebra di una dimensione che pensavamo essere la psicologia deviata dei replicanti, ma che in realtà non era nient’altro che il riflesso fin troppo fedele della condizione umana.
Sui replicanti come simulacri nell’accezione di Jean Baudrillard molto si è scritto. Qui aggiunto solo che l’assenza di Rutger Hauer e del suo Batty rappresenta forse l’unica macchia che si può contestare allo straordinario lavoro svolto da Denis Villeneuve con il seguito Blade Runner 2049. L’importanza di Roy Batty era stata intuita da K. W. Jeter nei suoi seguiti ufficiali, ma senza che neanche lui riuscisse a mio avviso a sviscerare bene le risorse offerte ai possibili sviluppi narrativi da una dimensione tanto complessa: l’immane riserva di carisma, profondità, problematicità anche (quale il rapporto di Batty con l’umano di cui aveva ereditato i ricordi e almeno parte del patrimonio genetico?), rimane del tutto inesplorata.
E la dipartita dell’uomo che era Roy Batty rende ormai del tutto speculativa qualsiasi ipotesi di futuri sviluppi in quella direzione.
 Rutger Hauer, 23 gennaio 1944 – 19 luglio 2019. In memoriam.
Rutger Hauer, 23 gennaio 1944 – 19 luglio 2019. In memoriam.Segnali dal futuro è la nuova pubblicazione dell’Italian Institute for the Future, associazione fondata a Napoli e attiva nel campo dei future studies: un’antologia di racconti di anticipazione selezionati da Roberto Paura e Francesco Verso, che delineano possibili scenari futuri spaziando “dall’intelligenza artificiale all’espansione umana nello Spazio, dalla disoccupazione tecnologica alla vita all’interno di mondi virtuali fino al sogno di replicare la coscienza umana”, introdotti da altrettanti saggi di esperti del settore (Massimo M. Auciello e Rino Russo, Riccardo Campa, Roberto Paura, Valerio Pellegrini, Emmanuele J. Pilia).
Napoli e attiva nel campo dei future studies: un’antologia di racconti di anticipazione selezionati da Roberto Paura e Francesco Verso, che delineano possibili scenari futuri spaziando “dall’intelligenza artificiale all’espansione umana nello Spazio, dalla disoccupazione tecnologica alla vita all’interno di mondi virtuali fino al sogno di replicare la coscienza umana”, introdotti da altrettanti saggi di esperti del settore (Massimo M. Auciello e Rino Russo, Riccardo Campa, Roberto Paura, Valerio Pellegrini, Emmanuele J. Pilia).
L’iniziativa, che non ha precedenti in Italia, si ispira a progetti analoghi che da sempre vengono sviluppati altrove. Un esempio storico è rappresentato dall’Institute for the Future di Palo Alto, tra le cui pubblicazioni recenti si segnala una raccolta di questo tipo intesa a “rendere tangibile il futuro”, con contributi di sei firme di spicco del panorama SF globale (tra gli altri Bruce Sterling e Cory Doctorow) sul tema della Internet of Things: An Aura of Familiarity. Altri esempi altrettanto rappresentativi sono il Project Hieroglyph curato da Neal Stephenson (di cui abbiamo parlato), l’antologia celebrativa dei cinquant’anni di Spectrum, Coming Soon Enough (con Greg Egan e Nancy Kress), oppure la serie Twelve Tomorrows pubblicata con cadenza annuale dall’MIT.
Segnali dal futuro prende le mosse dalla sessione introduttiva del Congresso Nazionale di Futurologia 2014 e si propone di offrire cinque assaggi possibili del mondo in cui domani potremmo svegliarci. Perché, come abbiamo imparato, il modo migliore per prevedere il futuro è inventarlo. Nell’antologia troverete anche un mio racconto ispirato al tema del mind uploading, ma che si trova a sfiorare anche altri campi a cui sono particolarmente interessato: l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ecologica, la transizione verso un modello di società post-capitalista, l’ubiquitous computing, il turismo virtuale, le città iperconnesse (come Dubai o la megalopoli del Delta del Fiume delle Perle) la riproducibilità della memoria, gli spazi simulati e i diritti degli esseri artificiali. Con una spruzzata della poetica visionaria di William S. Burroughs e di Makoto Shinkai. Il tutto dal punto di vista di un… no, stavolta niente detective, solo un ingegnere elettronico.
Il racconto s’intitola La vita nel tempo delle ombre, è introdotto da un saggio di Emmanuele J. Pilia (esperto di transarchitettura, ma non solo) e si accompagna ad altri quattro racconti firmati da totem come Ken Liu o Francesco Grasso e autorevoli esponenti dell’ultima ondata di fantascienza italiana come Clelia Farris e Francesco Verso.
Il libro è in vendita a 9,90 euro sul sito dell’IIF.
Novembre 2014. Non siamo a Los Angeles ma mancano comunque 5 anni al futuro di Blade Runner. Un futuro di spinner capaci di librarsi in cielo per sfuggire al traffico impantanato nei bassifondi, di ESP capaci di navigare nello spazio tridimensionale delle fotografie, di perturbazioni monsoniche su scala planetaria, di tecnologie genetiche a buon mercato e di replicanti. Il futuro immaginato da Ridley Scott (e Hampton Fancher, e David Peoples, e Syd Mead… sulla scorta ovviamente delle visioni del Cacciatore di androidi di Philip K. Dick) è dietro l’angolo e presto busserà alla porta. Un futuro sporco, violento, inquietante, sovrappopolato – laddove, vale la pena notarlo, nel romanzo di Dick era invece desolato e spopolato, per le conseguenze di un olocausto nucleare, e per questo inquietante esattamente per le ragioni opposte. Comunque un futuro in larga misura indesiderabile per chiunque ne prese visione al cinema, nell’anno di distribuzione della pellicola. Ma come è cambiata la nostra percezione di quel futuro nell’arco di questi 32 anni, dal 1982 ad oggi?
Quello di Blade Runner è un futuro monco. Manca della rete, che è pur sempre la maggiore innovazione del secolo scorso, nonché forse la tecnologia di massa più rivoluzionaria nella storia dell’umanità, almeno nel momento in cui scrivo queste parole, e voi le leggete. Eppure è un futuro che sembra promettere più di quello che abbiamo avuto: le stazioni spaziali, un qualche tecnologia capace di mantenere voli di linea interplanetari (se non proprio interstellari), tra la Terra e le colonie extra-mondo. È un futuro incompleto, parziale, come spesso accade alla fantascienza. Nondimeno è un futuro vivido, efficace, dall’impatto sconvolgente, capace di far presa ancora oggi sull’immaginario dello spettatore.
È tornata alla ribalta proprio in questi giorni la notizia del sequel a cui Scott starebbe lavorando ormai da tempo. Dopo l’entusiastico annuncio della scorsa estate sulla sceneggiatura ultimata da Michael Green e Hampton Fancher, sembrerebbe che Scott, visti i precedenti impegni assunti con Prometheus 2 e The Martian, abbia deciso di abbandonare la cabina di regia per ritagliarsi un ruolo da produttore. Il che non è necessariamente una brutta notizia. Non è ancora noto chi lo sostituirà dietro la macchina da presa, ma si dovrebbe cominciare a girare già il prossimo anno.
L’affresco distopico di Blade Runner ha segnato l’immaginario di un decennio e continua a esercitare la sua influenza ben oltre i confini dell’esperienza del cyberpunk. E forse è il caso di porsi qualche domanda sul perché quel tipo di futuro è tutto sommato ancora oggi così penetrante, pur risultando alterato il messaggio del film. Il tempo è stato di certo galantuomo nei confronti dell’opera di Scott, ma soprattutto perché si è saputo dimostrare particolarmente severo nei confronti del nostro mondo. Il nuovo Blade Runner saprà cogliere lo spirito dei tempi come il suo predecessore?
In questa realtà, siamo in tanti – decisamente troppi – a svegliarci ogni mattina nella pelle morta di un replicante. Siamo tutti simulacri, prigionieri di un domani che non ci appartiene e che non presenta sbocchi per le nostre aspirazioni, per l’esercizio dei nostri sogni, per l’applicazione della nostra libertà. Viviamo in un incubo, con l’ossessione di un cacciatore di taglie messo sulle nostre tracce per riscuotere il premio del ritiro. E forse ci riuniremo in sala, fra un paio d’anni, per esercitare il rito collettivo della visione del simulacro di un film che parla di noi. Siamo lavori in pelle. E mancano ancora 5 anni al 2019.
Se l’universo pullula di vita, dove si sono cacciati tutti? Se lo chiedeva già Enrico Fermi, formulando quello che sarebbe divenuto uno dei paradossi più popolari del secolo scorso, benché forse apocrifo. E qualche anno dopo Frank Drake provava a sistematizzare il problema ricorrendo all’eleganza della matematica. Sullo strano silenzio che sembra regnare nel nostro cielo si è a lungo discusso e si è scritto molto. Sono state formulate numerose ipotesi e scritti ottimi libri, non ultimo il testo di Paul Davies che non mi stancherò mai di citare. Ne abbiamo parlato.
Ma adesso dalle colonne di io9 George Dvorsky lancia una provocazione. Suggerisce di considerare l’ipotesi a cui nessuno vuole credere. E allora consideriamola anche noi. Riflettiamoci un momento. Eccola: forse, se non abbiamo ancora intercettato segnali di attività da parte di civiltà extraterrestri, non è perché i nostri vicini cosmici si stiano nascondendo. Forse non è in atto nessun piano di elusione della comunità galattica nei confronti degli arretrati/potenzialmente-pericolosi/insignificanti/accidentalmente-dannosi/noiosi abitanti della Terra. Forse, se finora non abbiamo trovato tra le stelle tracce di vita intelligente e tecnologicamente progredita, è semplicemente perché lì fuori non c’è nessuno. Perché siamo soli. Punto.
Siamo l’eccezione. E questa è la consapevolezza terminale, l’ultima verità che dobbiamo accettare.
Magari c’è vita, là fuori, ma non è vita senziente. Forse, per citare Rustin Cohle (e Thomas Ligotti), “human consciousness is a tragic misstep in evolution“. Siamo solo un errore di programmazione. Un passo falso nel cammino dell’evoluzione.
Oppure c’è vita là fuori, e come noi si è appena sollevata dal fango in cui finora ha strisciato e sta muovendo i primi passi sulla scala dell’evoluzione tecnologica. E come noi ha i millenni contati per originare una civiltà tecnologicamente avanzate (ATC), prima di essere spazzata via dal prossimo cataclisma cosmico in forma di gamma-ray burst. Magari, uno scarto tecnologico di qualche secolo ci separa dai nostri vicini, che resteranno invisibili ai nostri tentativi di rilevamento solo per l’intervallo necessario a colmare questo gap.
Oppure spingiamoci oltre. Consideriamo pure l’ipotesi più estrema di tutte. Il terzo tipo di solitudine: là fuori non c’è niente ad aspettarci. Niente.
Perché tutto ciò che interessa a chi sta facendo girare questo universo è confinato qui sulla Terra, o comunque è da qui che prende origine. E non è detto che il demiurgo di questa realtà sia necessariamente un’entità maligna. Il nostro potrebbe essere sì un universo simulato, ma avere comunque uno scopo ben definito. Uno scopo che obbliga i suoi costruttori a simulare con la massima risoluzione solo una minima parte del vero universo, mentre per il resto possono limitarsi a un’approssimazione e risparmiare potenza di calcolo. E allora ecco che lo spazio al di là dei confini del sistema solare, al di fuori della nostra portata, si riduce a un ologramma vuoto e silenzioso, mosso solo dall’applicazione delle leggi fisiche di base. Nessun personaggio in attesa, là fuori. Nemmeno l’ombra di qualche NPC…
Il gioco è tutto per noi e ci tocca giocare la nostra partita da soli. A voi la prossima mossa.
Dopo la scorribanda di questi ultimi giorni sulle intelligenze artificiali superumane e gli universi-simulacro, voglio lanciarvi una provocazione. Vi propongo quindi un rompicapo, lo stesso proposto dall’utente Roko di LessWrong, una comunità molto attiva su alcuni campi della riflessione transumanista, e che gli ha meritato l’espulsione dal forum. Dal suo nickname e dalla creatura mitologica in grado di pietrificare con il semplice sguardo, il dilemma ha preso il nome di Roko’s Basilisk. In che consiste?
Immaginate che in un futuro più o meno lontano una IA superumana veda davvero la luce e che una IA maligna da essa generata decida di scoprire chi ha partecipato attivamente al suo avvento, e chi no. La IA istanzia una simulazione di tutte le coscienze umane che l’hanno preceduta e verifica il loro comportamento. Se avete dedicato la vostra vita al perfezionamento dell’IA e al suo avvento, il Basilisco vi premia – vi risparmia la vita, oppure lascia che la vostra vita simulata vada avanti senza che voi vi accorgiate di niente. In caso contrario, vi condanna a un’eternità di tormento.
Forse siamo già nella simulazione. Forse Dick non aveva poi torto. Forse, qualcuno sta osservando la nostra condotta di azione per decidere cosa fare di noi. Non è un bell’augurio, ma sappiate che se un giorno ci rivedremo potrebbe essere all’inferno!
Approfondimenti
- A proposito del Roko’s Basilisk: The Most Terrifying Thought Experiment of All Time
- Il punto di vista di Charles Stross sul dilemma di Roko: Roko’s Basilisk wants YOU
Attori disposti a tutto: scene pericolose o “semplicemente” audaci, ritmi massacranti, sessioni interminabili di riprese per cogliere il massimo grado di fedeltà alla visione dell’autore. Non sarebbe il sogno di ogni regista? L’agenzia francese ADN, attiva dal 2011 nel settore degli effetti speciali, ha deciso di concentrarsi sul business delle controfigure digitali: autentici cloni virtuali di attori in carne e ossa, grazie alle sofisticate tecnologie di scansione già adoperate da una decina di studi in tutto il mondo, dall’America alla Nuova Zelanda, passando per il Regno Unito. Ma a differenza dei concorrenti, ha deciso di investire anche nella gestione legale degli avatar, oltre che nella loro creazione. Insomma, il primo passo verso agenzie di attori virtuali sembra essere stato compiuto.
Se la cosa vi suona stranamente familiare, forse è perché ricordate ancora S1m0ne, bel film di Andrew Niccol con Al Pacino nel ruolo del regista pigmalione e la modella canadese Rachel Roberts in quello della sua creatura digitale. E in effetti durante la campagna di lancio del film, nel 2002, gli autori cercarono di far passare la loro protagonista per una costruzione virtuale, ma con scarso successo.
Forse ricorderete anche il discorso sviluppato su HyperNext a proposito delle nuove modelle di H&M, e dell’inseguimento disperato della perfezione idealizzata palesato in tanti comportamenti legati al mondo della moda. Senza voler scomodare Jean Baudrillard, qui siamo un passo oltre, con un piede nel futuro. La prima attrice italiana ad avere un simulacro di celluloide sarà Luisa Ranieri.
[Grazie a Lanfranco Fabriani per la segnalazione, che nasconde molto più di quanto ho potuto rivelare in questo post.]
































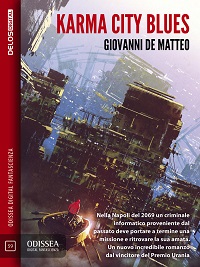


Interazioni recenti