You are currently browsing the tag archive for the ‘tecnologia’ tag.
Śūnyatā, ovvero “vacuità” in sanscrito, è un concetto che nella dottrina buddhista indica una condizione ontologica su cui si fondano diverse scuole di pensiero, non ultima quella del monaco Nāgārjuna, per il quale tutti i fenomeni (dharma) sarebbero privi di identità e niente possiederebbe una natura indipendente. Ulteriormente estesa, la dottrina del Śūnyatā afferma che la realtà non è dotata di esistenza intrinseca, ma sorge solo da una “originazione interdipendente”, in cui ogni entità esiste solo in relazione alle altre e ogni cosa esiste solo nell’interconnessione con tutto il resto. In altre parole, tutto è connesso con tutto, un approccio sostenuto anche da Carlo Rovelli nell’interpretazione relazionale della meccanica quantistica che ha contribuito a formulare ormai trent’anni fa e a sostenere per tutto questo tempo.
È (anche) intorno a questa idea che si sviluppa, al di là delle intenzioni stesse del suo autore, il volume omonimo dato alle stampe da Eris Edizioni, che ha cominciato a far discutere molti addetti ai lavori e appassionati (si legga per esempio qui e qui) ancora prima della sua uscita. Un graphic novel che è allo stesso tempo un’opera d’arte concettuale e un conte philosophique, un organismo ibrido e sintetico che si propone di esplorare le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale generativa (AGI), inserendosi nella maniera più intelligente ed efficace possibile nel dibattito sul ruolo delle AI nell’industria culturale, e sull’impatto dei nuovi strumenti di produzione addestrati con dataset (di dominio pubblico o meno) sui sempre più fragili equilibri di un settore già in crisi. Che poi, con attori e tecnologie diverse, è un confronto che ha conosciuto diverse stagioni, ma affonda le radici già nelle prime forme di automazione del lavoro umano. Solo che qui cominciamo a spostarci dalla dimensione fisica a quella concettuale, e il discorso si fa immensamente più articolato, complesso e interessante.
Francesco D’Isa, filosofo, artista digitale e romanziere, nonché direttore editoriale della rivista culturale L’Indiscreto, aveva già dedicato al tema estese e approfondite riflessioni. Ma probabilmente è con quest’opera che guadagna un vantaggio forse incolmabile rispetto alle voci contrarie, barricate su posizioni destinate a essere spazzate via dal corso degli eventi: non perché gli oppositori delle AGI siano indistintamente dalla parte del torto, ma perché la legge di Riepl sta già trascinando alla deriva i loro argomenti come resti di un naufragio sospinti dalla corrente del tempo.
Quello di D’Isa con Sunyata è un tentativo di rendere esplicite le potenzialità di una tecnologia di cui abbiamo solo cominciato a intravedere qualche raro, sporadico e incoerente barlume. La trama del volume è talmente rarefatta da risultare poco più di un pretesto. Eppure, mescolando meditazione e simbolismo con una sensibilità molto vicina alle filosofie orientali, riesce ad addentrarsi nello spazio ancora inesplorato in cui si incontrano le potenzialità della macchina e la creatività umana, dove possibilità ancora latenti attendono di essere destate per estrinsecare tutta la loro carica dirompente, alimentando i sogni delle AI con fantasie e ansie umane e, viceversa, mettendo a disposizione della mente umana il fuoco di un potere tecnico potenzialmente immenso.
D’Isa ci conduce così per mano in una dimensione onirica, in cui la realtà si specchia e con lei si specchia anche l’identità della protagonista, che finisce per scindersi in una pluralità di soggetti interdipendenti, in relazione l’uno con l’altro. La chimera, che come le fiere dantesche le si presenta nel corso del suo vagare per una selva di simboli, è dapprima fonte di spavento e poi di un’ambigua fascinazione, e sembra incarnare l’ambivalenza delle tecnologie TTI (text-to-image) contro cui è stata canalizzata la polemica degli ultimi mesi.
Il discorso, come sottolinea l’autore nella sua preziosa introduzione, si fa presto politico. Prendendo in prestito le parole di Noam Chomsky, citato da D’Isa in un suo recente post sui social:
“La maggior parte dei pericoli e dei limiti delle AI può essere riassunta nei limiti del dataset che rappresenta il loro mondo cognitivo. È vitale che questo sia il più aperto e inclusivo possibile, oltre che modificabile e trasparente, in modo da non offrire delle AI che parlano (e impongono) solo un mondo culturale. Ogni proposta che ostacoli la massima apertura del dataset come il copyright è da rifiutare con forza“.
Noam Chomsky, New York Times (8 marzo 2023)
Per quanto la sua suggestione sia innegabile, Sunyata si può dire un’opera riuscita solo in parte, e paradossalmente è in questa incompiutezza che risiede il suo successo più grande, dal momento che se la componente narrativa si risolve in una parziale evoluzione delle sue esili premesse, è la parte grafica, senz’altro la componente più sperimentale del progetto, a risplendere sfolgorante e a gettare nuova luce – e nuove ombre – sul futuro che già muove i primi passi tra di noi.
Di cosa parliamo quando parliamo di cyberpunk? La risposta è molto meno scontata di quanto potrebbe sembrare a un approccio superficiale. Il cyberpunk letterario è stato spesso accusato di scarsa originalità, monotonia di fondo e, col tempo, conformismo a tutta una serie di elementi divenuti un po’ dei cliché: il mondo distopico dominato dalle multinazionali, gli hacker solitari in lotta contro il sistema, la vita di strada nei bassifondi delle megalopoli… e potremmo continuare. Ma se prendiamo in considerazione i due titoli che hanno contribuito maggiormente a plasmare la nuova sensibilità della fantascienza dagli anni ’80 in avanti, ci accorgiamo di tutta una serie di differenze anche abissali legate non a elementi di contorno, che tutto sommato sono anche abbastanza sovrapponibili (*) – come dimostrano anche le dichiarazioni di William Gibson sulla sua esperienza come spettatore in sala all’uscita di Blade Runner – ma su un elemento che per il cyberpunk è tutto fuorché accessorio: la tecnologia.
(*) E che così di contorno, come vedremo tra poco, comunque non sono.
La tecnologia in Neuromante
Partiamo da Neuromante, il manifesto letterario del cyberpunk. Uscito nel 1984, è ambientato secondo le stime di Gibson intorno al 2035 (sebbene l’arco della trilogia copra 16 anni e quindi questa datazione vada presa molto con le molle, potendo oscillare, diciamo, tra il 2025 e il 2040… ma tutto sommato ancora dietro l’angolo, a differenza di quanto dedotto invece da un lettore su Vice basandosi su altri elementi interni ai romanzi ma probabilmente più dovuti a sviste dell’autore che non riconducibili alle sue reali intenzioni) e dipinge una tecnologia ormai smaterializzata, micro- e nanometrica, pervasiva.
Nel mondo di Case e Molly, la tecnologia si è ormai integrata in maniera indistricabile con i corpi e la psiche degli utenti: il cyberspazio è un piano dell’esistenza complementare alla realtà fisica, con cui si compenetra in declinazioni che assumono di volta in volta le forme di un’internet ante litteram, della realtà virtuale o di una realtà aumentata, e che assolve al ruolo di vero e proprio ecosistema, con le sue nicchie e i suoi agenti (virus informatici, ICE, costrutti di personalità riconducibili al mind uploading, intelligenze artificiali…).
Case, Molly e gli altri abitanti del futuro come loro non esitano a modificare i propri corpi attraverso impianti prostetici che ne aumentano le facoltà e attivano un feedback con il cyberspazio: non sono più solo agenti, ma la loro psiche e il loro organismo diventa un target su cui la rete e altri agenti possono produrre effetti tangibili. La strada ha trovato il suo uso per la tecnologia uscita dai laboratori, per dirla con Gibson. Anzi, ha trovato mille modi per utilizzarla e piegarla alle necessità dei singoli operatori, attraverso tutto un mercato nero di tecnologie trafugate dai centri di ricerca delle multinazionali o dell’esercito e messe in circolazione da una rete di contrabbandieri, corrieri, rigattieri…
La tecnologia in Blade Runner
La visione della Trilogia dello Sprawl prende forma tra la fine degli anni ’70 e i primissimi ’80, e nel 1982 arriva nelle sale Blade Runner. Un film che si inserisce nel solco di quella visione cupa e pessimistica del futuro che negli stesi anni si andava definendo grazie a pellicole epocali come Mad Max di George Miller (1979) e 1997: Fuga da New York di John Carpenter (1981), o Alien dello stesso Ridley Scott (1979). Ma, con la notevole eccezione di quest’ultimo, i film che stavano ridefinendo l’immaginario del futuro erano prevalentemente accomunati da un basso tasso tecnologico: la tecnologia era o ridotta al puro elemento meccanico (le automobili di Mad Max con cui vivono in simbiosi i sopravvissuti dell’outback australiano) o a strumento di controllo (le bombe miniaturizzate iniettate a Plissken per convincerlo a esfiltrare il presidente dal carcere di massima sicurezza di Manhattan).
Lo stesso Alien non è che brilli sotto il profilo dell’estrapolazione tecnologica, ma se non altro, sullo sfondo di una civiltà che è stata comunque in grado di mettere in campo lo sforzo necessario a esplorare rotte spaziali al di fuori del sistema solare, presenta personaggi che sono androidi meccanici indistinguibili dagli esseri umani e computer che rasentano, per autorità anche se non proprio per flessibilità (e qui torniamo alle forme di controllo già citate sopra a proposito di 1997: Fuga da New York), lo status delle IA. Elementi che, con le dovute variazioni, caratterizzano anche Blade Runner, dove ritroviamo appunto una tecnologia pesante: gli avanzamenti nella biotecnologia hanno permesso lo sviluppo di replicanti, androidi biologici indistinguibili dagli esseri umani (anzi, più umani dell’umano), destinati all’impiego in teatri di guerra extra-mondo e a farsi carico di mansioni che richiedono forza e resistenza fisica. L’uso più soft contemplato per i Nexus-6, i replicanti di ultima generazione, è per i modelli femminili, adibiti alla prostituzione nei bordelli delle colonie, non proprio un esempio di visione futuristica sull’impiego del più sofisticato prodotto della tecnologia umana.
In Blade Runner, la tecnologia è sempre separata dai corpi e dalle menti dei suoi utilizzatori umani: l’intermediazione tecnologica nelle relazioni umane è ridotta al minimo, i telefoni sono ancora in cabine pubbliche, i computer quasi nemmeno si vedono e – tralasciando volutamente, per il momento, qualsiasi grande o piccola retcon operata da Blade Runner 2049 – la rete nemmeno esiste. La tecnologia non è bassa, ma è sostanzialmente hard e ha a che fare con la programmazione/manipolazione biologica dei corpi, confinata all’interno di questi (alcune decine o centinaia di migliaia di replicanti sparsi sulle colonie extra-mondo, e pochissimi fuggitivi clandestini sulla Terra), mentre il mondo di fuori è sostanzialmente la fucina di catastrofi ambientali in cui ci troviamo a vivere oggi, con un downgrade della tecnologia attuale a quella degli anni ’80.
Blade Runner & Neuromancer: convergenze non accidentali
Per inciso, ricollegandoci a quanto dicevamo in apertura sulla sovrapponibilità degli elementi d’ambiente e le atmosfere, è interessante anche notare come Gibson e Scott condividessero una visione sostanzialmente comune su quella che l’autore di Neuromante definisce “la più caratteristica delle nostre tecnologie“: la città. Entrambi, Gibson sulla pagina scritta e Scott nei set di Blade Runner, compiono un’operazione che potrebbe apparire scontata (soprattutto a un europeo, sostiene Gibson): sovrapporre elementi del passato, del presente e del futuro nella rappresentazione delle città. In pratica: dare evidenza della stratificazione delle epoche attraverso il mélange architettonico che plasma l’estetica della città.
Ciò che Ridley Scott fa con Blade Runner, lo si ritrova nella stessa misura sia in Neuromante che nei precedenti racconti di Gibson: le strade delle loro città sono concentrati di archeologia urbana e per questo danno una misura incontestabile del tempo che è corso su quelle superfici e di ciò che è costato.
Blade Runner vs Neuromancer: dove saltano gli schemi
Tutto semplice, quindi? Forse no, perché il doppio finale di Blade Runner, con il problema della duplice interpretazione della natura di Deckard, complica significativamente lo schema fin qui delineato. A seconda delle letture che si vogliono dare al personaggio, il cacciatore di replicanti può essere un umano (chiave interpretativa prediletta dall’interprete del ruolo Harrison Ford) o un replicante lui stesso (lettura sostenuta a più riprese da Ridley Scott, almeno fino all’uscita nelle sale del sequel di Denis Villeneuve che invece opta per la versione di Ford).
Se Deckard è un umano, la sua fuga finale con Rachael assume le valenze metaforiche di un matrimonio tra la sfera umana e quella artificiale, una sorta di romantica conciliazione tra la natura e la tecnologia. Poco plausibile forse, sicuramente suggestiva, estrinsecata in particolare nella sequenza dell’auto che attraversa i boschi a nord di Los Angeles sulle note incalzanti della leggendaria colonna sonora di Vangelis. Si tratta del finale voluto dallo sceneggiatore Hampton Fancher e realizzato da Scott su input della produzione “riciclando” le sequenze girate per Shining scartate da Stanley Kubrick.
Se Deckard al contrario è un replicante, la sua scoperta finale (molto in linea con la sensibilità di Philip K. Dick benché non fedele alla lettera al romanzo), suggellata dalla chiusura delle porte dell’ascensore scelta come final cut dal regista, diventa l’agnizione lacerante dell’incompatibilità della propria esistenza con la natura, l’anamnesi sul proprio essere – esattamente come i replicanti a cui il cacciatore ha finora dato la caccia – una contraddizione in atto, la prova «vivente» che la realtà ha ormai raggiunto un livello di falsificazione da cui è impossibile tornare indietro: non sono solo i ricordi a essere contraffatti, ma l’effetto si estende inevitabilmente alla percezione stessa della realtà. La natura è destinata a scomparire, sostituita da repliche che si credono originali e reali. Le superiori capacità mimetiche dei simulacri renderanno infine vano qualsiasi tentativo di resistenza.
La versione di Ford (e di Fancher) chiude in qualche modo un cortocircuito con la visione tecnologica di Neuromante, dove la sintesi tra organico e sintetico viene subita ma a cui non ci si sforza di resistere, cercando piuttosto di piegarla alle esigenze dei protagonisti: sotto questa luce, Blade Runner prospetta un’accettazione perfino ottimistica di questa sintesi, facendo quindi un ulteriore passo avanti.
La versione di Scott (e di Dick), invece, stabilisce che non c’è ragione di sposare ciò che è fuori con ciò che è dentro, l’organico e l’inorganico. Semplicemente, l’inorganico, l’artificiale, il sintetico, il simulacro, ormai più umano dell’umano, è destinato a soppiantare l’organico, il naturale, l’originale. Non c’è scampo, non esiste via di fuga, la partita è segnata.
Siamo sotto scacco, a una mossa di distanza dallo scacco matto. Solo che non ce ne siamo ancora resi conto.
A Chiba aveva visto svanire in due mesi di consulti e di esami i suoi nuovi yen. Gli esperti delle cliniche clandestine, la sua ultima speranza, avevano ammirato la maestria con cui l’avevano menomato, poi avevano scosso lentamente la testa.
Adesso dormiva negli alberghi bara più economici, quelli vicini al porto, alla luce dei riflettori alogeni che rischiaravano i moli tutta la notte come fossero enormi palcoscenici, là dove non si potevano vedere le luci di Tokyo a causa del bagliore del cielo televisivo, neppure il torreggiante ologramma della Fuji Electric Company, e la baia di Tokyo era una nera distesa in cui i gabbiani volteggiavano sopra masse di bianco polistirolo espanso alla deriva. Dietro al porto iniziava la città, le cupole delle fabbriche dominate dagli enormi cubi delle arcologie delle multinazionali. Il porto e la città erano separati da una stretta linea di confine fatta di strade più vecchie, un’area che non aveva un nome ufficiale. Night City, con Ninsei nel suo cuore. Durante il giorno i bar di Ninsei erano chiusi e anonimi, i neon spenti, gli ologrammi inerti, in attesa sotto il velenoso cielo argento.
Tratto da Neuromante, William Gibson
(Mondadori, 2011 – traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli, pagg. 8-9)
In questa galleria di Stefano Gardel, fotografo italiano basato in Svizzera, l’immaginario distopico e le atmosfere cyberpunk di film come Blade Runner e Akira rivivono negli scatti notturni presi per le strade di Tokyo e Osaka. L’abbinamento con le parole di Gibson è inevitabile.
Nostalgia di un futuro già passato.
Altre magnifiche composizioni (incluse le gallerie Dystopia, Electric Lines, Looming Kowloon e Pervading Darkess) sul suo sito.
Domenica prossima si chiuderà la quarta edizione di Foto/Industria, biennale di fotografia dell’industria e del lavoro curata da Francesco Zanot per la Fondazione MAST di Bologna. Il tema, che risulterà particolarmente caro a chi frequenta queste pagine, è la Tecnosfera, come è stato definito dal geologo Peter Haff “l’insieme di tutte le strutture che gli esseri umani hanno costruito per garantire la loro sopravvivenza sulla terra”, uno strato artificiale “con un peso stimato di decine di miliardi di miliardi di tonnellate”.
Io ho avuto la fortuna di visitare con la guida dell’artista una delle mostre realizzate sul tema, che raccoglie gli ultimi lavori di Délio Jasse. Ne ho parlato su Quaderni d’Altri Tempi questa settimana. E ve la consiglio incondizionatamente, insieme agli altri nove allestimenti realizzati nel centro storico di Bologna. Tempo (climatico e cronometrico) permettendo.
Stamattina, andando in ufficio, ascoltavo un dibattito in radio sull’impatto che l’automazione avrà nei prossimi anni sul mondo del lavoro. Un po’ tutti abbiamo sentito o letto gli annunci apocalittici che nei giorni scorsi sono circolati sulla stampa: i titoli più sobri parlavano del furto del lavoro ai danni degli umani perpetrato dalle nuove generazioni di robot, e scaricavano implicitamente sulla tecnologia le responsabilità occupazionali delle politiche inadeguate o fallimentare che da anni vengono perseguite un po’ in ogni parte del mondo.
Il prossimo passo, che vedo già in atto, consisterà probabilmente nell’associare la figura del robot a quella dell’immigrato che s’introduce nel nostro sistema per recare danni più o meno profondi e inguaribili al nostro stile di vita consolidato (si fa per dire). Ho provato un senso di disorientamento, ascoltando il botta e risposta tra la giornalista e l’intervistato, un esperto di nuove tecnologie membro di un’associazione di cui purtroppo non ricordo al momento il nome. Non per i contenuti, ma per la realizzazione che solo qualche anno fa, diciamo quando ho visto per la prima volta Blade Runner a metà anni novanta, o quando ho iniziato a cimentarmi a mia volta con la scrittura del futuro a metà anni zero, un dibattito radiofonico del genere, proiettato nel 2016, mi sarebbe sembrato più che logico, perfino naturale.
Il mio disagio attuale, che ho comunque fatto presto a scacciare, nasce – mi rendo conto – dall’assuefazione all’altra realtà, quella contigua all’immaginario in cui siamo cresciuti, ovvero la realtà fattuale o presunta tale costruita dall’interazione degli abitanti e dei sistemi informazionali del pianeta Terra, gli inforgs di cui parla Luciano Floridi. Quella realtà raccontata che, malgrado tutto, negli ultimi anni sta facendo di tutto, attraverso le sorgenti di condizionamento che “ispirano” e “orientano” l’opinione pubblica (governi, organizzazioni economiche, istituzioni religiose, editori), per provare a convincerci di vivere in Anni Oscuri, in un nuovo medioevo, imponendoci il diritto di non avere diritti come una nuova frontiera della libertà, riscrivendo il mondo perché possiamo godercelo così com’è, anzi accettando e plaudendo alle mille forme di erosione che quotidianamente agiscono sul blocco sempre più friabile dei diritti acquisiti.
E invece, ci accorgiamo adesso, il mondo reale è andato avanti. Non è più quello degli anni ’90, è un mondo in cui è davvero naturale, a pensarci bene, imbattersi per radio, andando al lavoro, in un dibattito sulle conseguenze e le implicazioni dell’impiego dei robot. È questo il mondo in cui viviamo, con buona pace per i reazionari e gli oscurantisti di ogni categoria, inclusi quelli che proprio in questi giorni si stanno sforzando per dimostrare al mondo, se mai ve ne fosse ancora bisogno, quanto arretrata e inadeguata sia la nostra classe politica quando si tratta di scegliere tra l’estensione dei diritti e l’esclusione dagli stessi.
Il luddismo di ritorno che sembra di intravedere tra le righe dei commenti di questi giorni non sorprende affatto, date le premesse. A conti fatti, a chi gioverebbe un’analisi precisa degli effettivi costi e benefici dell’impiego di sistemi artificiali in sostituzione della manodopera umana in contesti rischiosi o magari in mansioni ripetitive, a bassissimo contenuto qualitativo o intellettuale? Molto meglio che un uomo svolga un lavoro meccanico: è stato fatto tanto per insegnargli a non lamentarsi, a occupare le proprie giornate in catena di montaggio, a rispettare la gerarchia e le consegne, non vorremo rinunciare proprio adesso ai magnifici risultati raggiunti nel campo del condizionamento umano? E proprio adesso che stiamo risolvendo gli ultimi problemi ereditati dal Novecento, perché dovremmo accollarci la fatica di pensare a soluzioni nuove, adatte ai tempi che corrono, capaci di garantire maggiori opportunità a sempre più gente, di spalancare gli orizzonti di nuove possibilità a masse che sono state addomesticate a credere che la più grande conquista dell’umanità siano state una casa ipotecata, un lavoro sottopagato, lo smartphone alla moda e una piattaforma televisiva da 500 canali?
Per fortuna il mondo va avanti. E sarà difficile spiegare a un’intelligenza artificiale quale sia il valore aggiunto di una massa lobotomizzata, asservita al volere di pochi, grassi padroni. Insieme ai lavori di più bassa manodopera, magari delegheremo ai robot anche l’onere delle rivendicazioni di quei diritti di cui non abbiamo voluto farci carico.

Nell’articolo scritto a 4 mani con il critico, traduttore e studioso di letteratura americana Salvatore Proietti, docente all’Università della Calabria, pubblicato sul numero 72 di Robot, ci siamo dilungati su un tema che attraversa, in maniera più o meno evidente, un numero crescente di opere prodotte negli ultimi anni in seno alla fantascienza: i diritti delle creature artificiali.
L’evoluzione tecnologica ha comportato effetti che non possono più essere ignorati: uno su tutti, la smaterializzazione dello spazio delle relazioni umane, con il web che è ormai diventato, come lo definisce il giurista Stefano Rodotà (al lavoro proprio su una Carta dei diritti di Internet con la commissione che presiede, costituita dalla Presidenza della Camera), il “più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto”, e che anche per questo necessita di una regolamentazione riconosciuta a livello transnazionale. Si tratta dello spazio in cui si svolge ormai gran parte delle nostre esistenze, quello che il filosofo Luciano Floridi chiama Infosfera e che ci rende tutti inforgs, organismi informazionali, soggetti ibridi.
L’identità personale si fa distribuita e si moltiplica. Il nostro ecosistema si è già modificato perdendo le originali presunte connotazioni di purezza naturale, e le prime applicazioni di augmented reality rendono ineludibile questa verità. Le tecnologie emergenti, sempre più spesso raccolte sotto la sigla NBIC (che raggruppa nanotecnologia, biotecnologie, information technology e cognitive science), adottato anche dalla National Science Foundation americana, producono effetti che diventeranno sempre più profondi e irreversibili man mano che si realizzano forme di convergenza tra i diversi settori della ricerca. Quanto dovremo ancora aspettare prima che soggetti che non condividono la nostra stessa natura biologica comincino a rivendicare i loro diritti? Robot, androidi, cyborg, intelligenze artificiali, cloni, simbionti, creature ibride, dalla duplice natura, prefigurano la nuova realtà di un mondo che non può più trincerarsi dietro l’esclusività dei benefici e dei diritti della contemporaneità, ma che anzi deve lavorare su una logica inclusiva per estenderli a tutti.
In un celebre passo della Dichiarazione di Indipendenza, ratificata nel 1776 a Philadelphia dai cittadini delle tredici colonie che si erano sollevate contro la madrepatria, leggiamo:
Sono istituiti tra gli uomini governi, i cui legittimi poteri derivano dal consenso dei governati; di modo che, ogniqualvolta una forma di governo tenda a negare tali fini, il popolo ha il diritto di mutarla o abolirla, e di istituire un nuovo governo, fondato su quei principi e organizzato in quella forma che a esso appaia meglio atta a garantire la sua sicurezza e la sua felicità.
Parole scritte da uomini, per esprimere la loro idea su quali condizioni debba rispettare un governo di altri uomini per essere da loro accettato. Qualcuno ha idea del perché un’intelligenza artificiale dovrebbe accontentarsi di qualcosa di meno di quanto richiesto dagli uomini?
Da questa consapevolezza nasce un approccio etico, come quello proposto nel 2006 da Gianmarco Veruggio, direttore della Scuola di Robotica di Genova e promotore della cosiddetta roboetica, l’etica applicata alla progettazione e allo sviluppo nei campi della robotica e dell’automazione. All’aumentare dei benefici potenziali, nella robotica come in qualsiasi altro settore della ricerca aumentano anche i rischi. Per questo la presenza massiccia di creature artificiali nel futuro verso cui ci stiamo muovendo pone l’opportunità e anzi il bisogno di una riflessione sulle regole che dovranno gestire il rapporto tra umani e macchine.
Prima che la realtà ci presenti un conto da pagare – come insegna la storia – comprensivo di interessi.
Il mondo in cui viviamo ci obbliga a misurarci continuamente con noi stessi. Per tenere il passo dei cambiamenti in corso non possiamo fare a meno di riconsiderare le certezze acquisite e da quelle muovere verso la prossima conquista, attraverso un processo dinamico. La frontiera di oggi non è quella di ieri, non sarà quella di domani.
Mi piace considerare la fantascienza come la letteratura del cambiamento, intendendo il raggio di questo cambiamento nella sua accezione più ampia. Se è vero che il richiamo alla scienza è dichiarato fin dalla prima formulazione di Hugo Gernsback (quel scientifiction derivato nel 1926 da scientific fiction, che si sarebbe infine evoluto nell’attuale science fiction), è altrettanto vero che nel corso del tempo il genere ha inglobato territori di frontiera che possono anche non avere un aggancio diretto con l’estrapolazione scientifica e tecnologica. Pensiamo per esempio al ricco e celebrato filone delle ucronie, ai viaggi nel tempo, alle opere di fantapolitica o anche alle distopie, che non necessariamente presuppongono il ricorso a tematiche scientifiche per dispiegare al meglio le dirompenti potenzialità del genere.
Qualcuno ritiene per questo preferibile sostituire alla science fiction la denominazione più “neutra” di speculative fiction, soprattutto in riferimento agli esiti letterari più alti. Nel mio piccolo ho invece fatto mia un’altra crociata, ovvero quella di sottolineare l’essenza del genere, esaltando l’ampiezza e la varietà del suo campo d’azione. La fantascienza elabora gli effetti del cambiamento sui parametri culturali che gli autori decidono di volta in volta di declinare: non solo la scienza, ma anche la storia, la sociologia, la politica.
Questo è per me la fantascienza. E per questo vale la pena leggerla e scriverla.
Il prossimo week-end si terrà a Napoli il primo Congresso Nazionale di Futurologia, organizzato dall’Italian Institute for the Future. Non un “congresso” accademico ma un appuntamento aperto al pubblico in cui esperti di molteplici campi s’incontreranno per ragionare insieme sugli scenari futuri in ambito scientifico, tecnologico, politico, economico.
Sei scenari per un futuro (non troppo) remoto è il tema portante di questa prima edizione, che avrà un’anteprima venerdì 7 novembre con un dialogo su “Uomo e macchina” con Lorenzo Pinna e una tavola rotonda sul futuro visto dalla fantascienza. E qui troverete anche il sottoscritto, insieme ai colleghi Dario Tonani, Francesco Troccoli e Francesco Verso, sotto l’attenta supervisione di Roberto Paura e Carmine Treanni.
 Il Project Hieroglyph nasce dal confronto di Neal Stephenson, autore di monumentali opere di fantascienza fortemente ancorate al sostrato tecnologico come Snow Crash, Cyptonomicon, il Ciclo Barocco e Anathem, con i docenti e i ricercatori della Arizona State University, che lo hanno invitato a considerare la possibilità di sviluppare, attraverso le sue opere, idee che potessero essere adottate e implementate sul breve-medio termine da scienziati, ingegneri, architetti. Esaltando, in questo modo, le caratteristiche della fantascienza di condizionare il progresso tecnologico. Il progetto, che ha subito attirato l’interesse di numerosi colleghi (da Bruce Sterling a Cory Doctorow, da Kathleen Ann Goonan a Elizabeth Bear, da Rudy Rucker a Charlie Jane Anders, in molti hanno contribuito con le loro storie all’antologia Hieroglyph curata da Ed Finn e Kathryn Cramer), è interessante soprattutto per un motivo: nasce programmaticamente per mettere a confronto le visioni di scrittori e scienziati e creare uno spazio comune di riflessione e discussione sul futuro, capace di autoalimentarsi attraverso una sorta di catena di retroazione positiva.
Il Project Hieroglyph nasce dal confronto di Neal Stephenson, autore di monumentali opere di fantascienza fortemente ancorate al sostrato tecnologico come Snow Crash, Cyptonomicon, il Ciclo Barocco e Anathem, con i docenti e i ricercatori della Arizona State University, che lo hanno invitato a considerare la possibilità di sviluppare, attraverso le sue opere, idee che potessero essere adottate e implementate sul breve-medio termine da scienziati, ingegneri, architetti. Esaltando, in questo modo, le caratteristiche della fantascienza di condizionare il progresso tecnologico. Il progetto, che ha subito attirato l’interesse di numerosi colleghi (da Bruce Sterling a Cory Doctorow, da Kathleen Ann Goonan a Elizabeth Bear, da Rudy Rucker a Charlie Jane Anders, in molti hanno contribuito con le loro storie all’antologia Hieroglyph curata da Ed Finn e Kathryn Cramer), è interessante soprattutto per un motivo: nasce programmaticamente per mettere a confronto le visioni di scrittori e scienziati e creare uno spazio comune di riflessione e discussione sul futuro, capace di autoalimentarsi attraverso una sorta di catena di retroazione positiva.
Martedì scorso Marco Passarello ne ha parlato su Repubblica Sera, in un articolo che riportava anche i punti di vista di alcuni autori italiani, tra cui anche il sottoscritto. Come riporta ora sul suo blog, Marco pubblicherà la versione integrale del pezzo, completa degli interventi di tutti gli autori consultati, sul prossimo numero di Robot. Intanto qui potete leggere l’articolo scritto per Repubblica. Dove mi sono scoperto nel ruolo del più possibilista tra tutti i colleghi italiani consultati sul progetto. La qual cosa, viste le cose che solitamente scrivo, potrebbe destare una certa incredulità. Rimando al prossimo numero di Robot per circostanziare meglio il mio pensiero, in maniera da non bruciare l’articolo integrale di Marco, e in questa sede riporto solo un breve estratto che forse serve a precisare meglio la mia posizione:
A mio avviso è solo collaterale la connotazione che pure si sta dando al progetto in relazione a un approccio
Author Neal Stephenson writes of a fictional 20km-tall tower constructed of steel (source: BBC News Magazine)
improntato all’ottimismo tecnologico. È solo un pretesto il ricorso alla contrapposizione verso il filone dei futuri distopici, pressoché dominante negli ultimi decenni, un espediente utile a marcare ulteriormente i contorni di questo tipo di fantascienza, con lo svantaggio di offrire una visione parziale, riduttiva e in definitiva ingrata della fantascienza più cupa. Dopotutto, come fa notare giustamente Annalee Newitz, altra importante personalità che ha aderito al progetto, anche nelle sue manifestazioni pessimiste la fantascienza non può essere liquidata come puro e semplice sensazionalismo nichilista: “[queste opere] nascondono anche imprevedibili messaggi di speranza. Se riusciamo a richiamare l’attenzione su questi avvertimenti immaginari […], allora possiamo anche immaginare le soluzioni prima che il disastro colpisca”.
Non dimentichiamo che William Gibson iniziò a presentarci [il cyberspazio] in storie oppresse da una pesante cappa di pessimismo. Eppure la tecnologia e l’uso che ne faceva la strada venivano presentate come risorse nelle mani dei preteriti, degli ultimi, dei reietti relegati ai margini della società, sottolineandone in tal modo la natura di arma a doppio taglio. È come se ogni distopia racchiudesse in sé, opportunamente camuffato, il seme di un’utopia.
Comunque, dal punto di vista strettamente critico, mi piace constatare come la mia posizione odierna sia abbastanza in linea con quella che esprimevo nel 2008 in relazione a un dibattito analogo in corso all’epoca nel mondo anglosassone. Lasciamo gli autori liberi di scrivere la fantascienza che preferiscono. Quello che conta è l’onestà di ciascuno di noi verso se stesso e verso i lettori.
Servono trucchi nuovi, adatti ai tempi moderni. Strategie adeguate a modellare una società in continua ridefinizione, esposta alla spinta di un’economia accelerata dal progresso tecnologico. Come dicevamo in precedenza: un nuovo paradigma.
Il corollario al paradosso del Grande Disaccoppiamento, come ci ricorda Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale intervistato da Riccardo Staglianò per Il Venerdì di Repubblica, è che:
Il PIL complessivo cresce, il salario medio no. Carl Benedikt Frey e Michael Osborne, docenti a Oxford, hanno calcolato che il 47 per cento dei mestieri attuali negli Stati Uniti è a rischio estinzione per l’informatizzazione. Lo strappo è violento e rapido.
E allora: ha ancora senso trovare per quel 43% di giovani italiani disoccupati lavori che entro la fine del prossimo decennio (se non prima) potrebbero risultare obsoleti, immettendoli in un circolo vizioso di necessità cronica di “riqualificazione”? Oppure potrebbe essere più logico trovare soluzioni temporanee per i disoccupati prossimi all’età pensionabile, pianificando al contempo la creazione di nuovi lavori e di nuove professionalità?
«Più i costi delle macchine si abbassano» osserva Lanier «più le persone sembrano costose. Una volta stampare un giornale era caro, quindi pagare i giornalisti per riempirne le pagine sembrava una spesa naturale. Quando le notizie diventano gratuite il fatto che qualcuno voglia essere pagato comincia ad apparire irragionevole». Così arriva Narrative Science, un software assembla-articoli, e Forbes lo recluta per redigere le brevi finanziarie. Oppure Warren (omaggio al miliardario Buffett), un programma che comincia a prendere il posto degli analisti di Borsa meno esperti. E poi TurboTax, che toglie il pane di bocca ai commercialisti che ci fanno il 740. Oppure quei programmi che riassumono per gli avvocati migliaia di pagine di documenti. E ancora, e ancora. Entro il 2025, stima McKinsey pensando all’America, gli aumenti di produttività informatica nelle aree dei «lavori della conoscenza» potrebbero rendere superfluo il 40 per cento dei posti attuali.
Se il 40% dei posti di lavoro attuali è a rischio, cosa fare di quei circa 700.000 giovani tra i 15 e i 24 anni attualmente senza lavoro? Un piano di supporto potrebbe aiutare a tamponare una situazione disastrosa. Una delle misure di contrasto alla Grande Depressione adottate da Franklin D. Roosvelt nell’ambito del New Deal consistette nell’istituzione dei Civilian Conservation Corps: un programma per l’impiego temporaneo di giovani disoccupati tra i 18 e i 25 anni, che al suo apice raggiunse le 300.000 unità di forza lavoro impegnata nella conservazione e nello sviluppo delle risorse naturali in zone rurali, e nel complesso tra il 1933 e il 1942 occupò 3 milioni di ragazzi. Non potremmo guardare anche noi ai nostri giovani disoccupati come una risorsa, invece che come una zavorra?
Ora, le condizioni in cui versa il territorio italiano sono abbastanza evidenti a tutti. Abbandono, incuria e abusivismo sono le cause all’origine di una debolezza strutturale messa a nudo dalle inondazioni, dalle frane e dai crolli che coinvolgono periodicamente il nostro Paese: da nord a sud, non c’è territorio che non sia toccato da fenomeni di dissesto idro-geologico. Per non parlare di quei miliardi di metri cubi di edifici pubblici o privati mai completati, o di quelle migliaia di edifici proliferati durante le ondate di speculazione edilizia che ormai intaccano e corrompono l’integrità estetica di quello che un tempo era il Paese Più Bello del Mondo. Le Comunità Montane sono state sempre più impoverite negli ultimi anni e nei comuni montanari gli effetti non tardano a vedersi. Strade e ferrovie versano in uno stato di incuria che prelude alla dismissione: e senza le strade e senza le ferrovie, viene meno l’asse portante della logistica al servizio dei flussi turistici. La messa in sicurezza del territorio e la riqualificazione del patrimonio urbanistico, delle strade e delle ferrovie, potrebbero essere il fronte su cui coinvolgere quell’enorme riserva lavorativa di cui disponiamo. Si fa un gran parlare di prevenzione, forse questo può essere il momento per dimostrare che non sono più solo vuote parole.
Inoltre un piano parallelo potrebbe essere messo in atto per la preservazione del nostro patrimonio artistico ed archeologico. Ed entrambi i rami sarebbero positivi anche in termini di “responsabilizzazione civile”: ai giovani andrebbe insegnato – o re-insegnato – l’interesse per la cultura, di cui per fortuna restano in giro più tracce di quante governi inutili o amministrazioni incompetenti siano riusciti a cancellare. Con i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea sono stati e continuano a essere organizzati corsi formativi per il rilascio di diplomi insignificanti: dirottiamo tutte queste risorse su un serio piano formativo per la tutela dei beni culturali. E ancora parallelamente cominciamo a istituire dei piani di orientamento allo studio davvero utili, controllando l’accesso ai diversi corsi universitari in base alla ricettività potenziale stimata per ciascun settore professionale.
Nel 2012, secondo il XV Rapporto Alma aurea sul Profilo dei Laureati Italiani, abbiamo avuto 227.000 laureati, ma tra il 2003 e il 2011 si è registrato un calo delle immatricolazioni del 17% e tra i 25 e i 34 anni i laureati rappresentano appena il 21% della popolazione (contro il 42% dei coetanei statunitensi). Il XVI Rapporto di AlmaLaurea sulla Condizione Occupazionale dei Laureati mette in evidenza come la quota di disoccupati, tra i laureati inclusi nella fascia 25-34 anni, tra il 2007 e il 2013 sia cresciuta dal 10 al 16%; tra i diplomati nella fascia 18-29 anni si è avuto un incremento dal 13 al 28%; tra i 15-24enni in possesso di una licenza media l’aumento è stato dal 22 al 45%. Evidentemente, i laureati subiscono la crisi meno dei loro coetanei con titoli di studio inferiori. Altrettanto evidentemente, il sistema scolastico italiano potrebbe fare di meglio, sia in fase di orientamento universitario che di inserimento lavorativo.
In questi anni, nonostante la crisi, abbiamo visto il paesaggio fisico-mediatico mutare radicalmente. Ormai buona parte delle nostre vite, dall’informazione alle relazioni sociali, dallo studio al lavoro, si svolge in uno spazio condiviso ma non materiale. E il cyberspazio di William Gibson si fonde con i mass media classici in quello che Luciano Floridi, tra i maggiori esperti di filosofia dell’informazione, ha definito Infosfera: la globalità dello spazio delle informazioni, che ormai comprende il mondo fisico e la stessa biosfera, e gli esseri viventi che lo costituiscono ne sono a loro volta parte integrante in quanto organismi informazionali (inforgs). Floridi parla di ambientalismo sintetico, inclusivo degli artefatti e degli spazi in continua generazione, suggerendo che dovremmo trattare tutta l’Infosfera in modo ecologico, prevenendo la distruzione o l’impoverimento gratuiti della realtà-infosfera.
Torniamo al duo Staglianò/Lanier:
«Per far emergere una nuova classe media bisogna rompere con l’idea insensata dell’informazione gratis. E creare un sistema di micropagamenti. Non solo per retribuire le merci che ora si scaricano free, ma anche chiunque lasci una traccia misurabile in rete. Di cui resterà proprietario». Un like su Facebook, un tweet ampiamente rilanciato, una ricetta condivisa online, ma anche la risposta a chi chiede come si ripara un mobiletto o il consiglio di un’infermiera su come cambiare la padella a un malato. Se diventano conoscenza hanno un valore, dunque devono avere un prezzo. […] Sì, ma in pratica? «Si dovrebbe modificare l’architettura del web, recuperando l’idea originaria di Ted Nelson. Nei primi anni 60 l’inventore dell’ipertesto immaginò una rete con link bi-direzionali, in cui chi ci cliccava poteva sempre risalire al punto di partenza». Chiunque riutilizzasse qualcosa prodotto da voi così dovrebbe citarvi. Riconoscendovi una parte dei suoi guadagni. In teoria non fa una piega, in pratica non sarà una passeggiata di salute.
Lanier conosce benissimo i limiti di applicabilità della sua idea: «Stiamo ragionando su astrazioni. Credo che fondamentale sia rompere l’incantesimo in cui siamo stati intrappolati sino a oggi. Fatto quel passo, la soluzione si troverà». All’Università di Pavia l’economista Andrea Fumagalli parla di reddito minimo che retribuisca le varie attività cognitive-relazionali. Resta il problema che, se anche remunerassimo chi lascia tracce digitali, non compenseremo tutti quelli che hanno perso un lavoro a causa dell’informatizzazione. Il Nostro: «I mestieri del mondo fisico non spariranno. Assistenti per gli anziani, massaggiatori, lavoratori di prossimità: le nicchie si moltiplicheranno. Più avanzati sono i nostri gadget elettronici, più costosi diventeranno i prodotti artigianali. La virtualità trasforma la fisicità in qualcosa di molto prezioso». Numeri più piccoli, però salari più alti per chi intercetta i nuovi bisogni.
Tutto ciò che diventa conoscenza ha un valore. E questo valore deve essere riconosciuto a chi è stato in grado di generarlo e diffonderlo come ricchezza. Tanto più che i progressi nella tecnologia potrebbero presto rendere obsoleto in concetto stesso di scarsità: nanotecnologie e biotecnologie daranno alla curva un impulso che al momento possiamo solo immaginare.
D’altro canto, è un principio che i lettori di fantascienza hanno già visto implementato in diversi contesti. Due titoli per tutti: L’Era del Flagello di Walter Jon Williams (The Green Leopard Plague, premio Nebula 2004) e Accelerando di Charles Stross (2005), rappresentano entrambi la prospettiva di una società agalmica, basata su un’economia della post-scarsità. A questo proposito riprendo quanto scrivevo all’epoca: di notevole interesse risulta la sintesi concettuale lasciataci da Robert Levin (alias lilo), pioniere del software libero e open source, purtroppo prematuramente scomparso nel 2006 a causa di un incidente d’auto: in The Marginalization of Scarcity, Levin definisce bene una società agalmica come un sistema a) cooperativo e non competitivo, b) antitetico alla nostra economia della scarsità, c) basato su abbondanza delle risorse e su equa allocazione delle stesse, d) a somma positiva (ogni guadagno non implica una perdita, ma il guadagno individuale spesso si accompagna a un profitto collettivo), e) decentralizzato e non autoritario. In un sistema agalmico il profitto non viene quantificato in un valore monetario, ma viene invece misurato attraverso parametri quali la conoscenza, la soddisfazione personale e un beneficio economico spesso indiretto. Ma il suggerimento di Lanier di implementare un sistema di micropagamenti potrebbe rappresentare una valida alternativa in continuità con il sistema attuale di valori economici. E pur con le sue luci e le sue ombre (di cui ha scritto proprio Stross, ripreso dal premio Nobel Paul Krugman), il sistema Bitcoin sembra contenere in nuce proprio questa possibilità, pur essendo poi piegato a scopi e usi completamente diversi (e largamente esecrabili).
Mi rendo conto che stiamo gradualmente scivolando nel campo dell’utopia. Ma pensando ai cambiamenti in corso, questo della reinvenzione dei mestieri e delle professionalità è solo una delle molteplici questioni che dovremo affrontare. A un livello più ideale, la progressiva emersione di sistemi artificiali via via più smart e intelligenti e i nuovi rapporti che nasceranno dall’interfaccia tra l’uomo e le macchine (HMI) nel settore della cognitive augmentation imporranno una piena ridefinizione del campo dei diritti. Ed è un’indagine a cui Stefano Rodotà ha dedicato la sua ultima fatica: Il diritto di avere diritti (Editori Laterza). Con Salvatore Proietti, a cui devo diversi spunti affrontati in questi due articoli, abbiamo approfondito il tema in un articolo di prossima pubblicazione su Robot. Ma di sicuro non è un discorso che si esaurirà presto.
(fine)
Con l’inizio della crisi in cui ancora ci dimeniamo per non annegare, il 2008 ha segnato uno spartiacque nella vita di ognuno di noi. Nel 2009, per la prima volta dal dopoguerra il PIL mondiale è caduto e per la prima volta dal 1982 il volume degli scambi commerciali si è contratto. Ciascuno nell’ambito del proprio vissuto, possiamo tutti riconoscere uno scarto del mondo in cui viviamo rispetto a quello precedente. Il potere di acquisto è crollato e la disoccupazione ha sfondato tetti che avrebbero potuto essere alti la metà per risultare già preoccupanti.
In Italia l’immobilismo politico dei nostri rappresentanti eletti (ma anche del nostro governo designato) non lascia presagire niente di buono per il prossimo futuro. Malgrado i ripetuti inviti all’ottimismo, gli annunci del governo vanno costantemente disattesi. Per di più, mi sembra che negli ultimi tempi, grosso modo proprio dall’insediamento di Matteo Renzi, ci sia stata una generale disattenzione da parte degli organi di informazione su tre problemi che difficilmente riusciranno a essere risolti con le politiche di procrastinazione in corso:
- La disoccupazione giovanile, che ha raggiunto a marzo quota 42,7%, contro una media europea di 23,7%, e ad aprile è salita al 43,2%, mentre nel resto d’Europa si attestava al 23,5% (con la Germania al 7,9% e l’Austria al 9,5%). Ormai non è più che stiamo bruciando una generazione: abbiamo già bruciato una generazione, che porterà le cicatrici addosso nei prossimi decenni, e con cui tutti dovremo fare i conti.
- Il divario tra esportazioni e domanda interna ha concesso in questi anni un po’ di ossigeno all’economia italiana. A fronte di un mercato interno generalmente depresso e di importazioni in calo del 10% nel solo biennio 2012-2013, le esportazioni hanno continuato a crescere fino ad agosto 2012 per poi attestarsi su livelli compressi tra i 32 e i 33 miliardi di euro di valore mensile. Significativo il dato del settore dell’automazione, che malgrado la forza dell’euro ha fatto registrare una crescita costante, dimostrando come il made in Italy non sia circoscritto all’alimentazione e all’abbigliamento, ma abbia anche qualcosa da offrire al campo della tecnologia. D’altro canto, il mercato interno non dà segni di ripresa, e in assenza di investimenti difficilmente riuscirà a risollevarsi. E sugli investimenti grava anche la forte incertezza legata a provvedimenti governativi quanto meno discutibili. [Solo sei mesi fa il premier in carica Enrico Letta poteva tornarsene raggiante dal Kuwait dopo aver strappato al fondo sovrano una promessa di investimenti nella Cdp per 500 milioni di euro (a fronte dei 1.600 miliardi di spesa potenziale che il paese del Golfo effettuerà nell’arco di quest’anno: detto in altre parole, l’Italia si era aggiudicata 31 centesimi per ogni 1.000 euro che il fondo avrebbe investito all’estero, e il nostro primo ministro festeggiava…) attirandosi gli improperi di Confindustria e Unimpresa e suscitando lo scherno di Repubblica. Stampa e associazioni delle imprese si sono rivelate tuttavia molto più benevole verso il suo erede, quando Renzi ha fatto passare il cosiddetto “decreto spalma-incentivi”, pubblicato in Gazzetta il 24-6-2014, destando l’allarme degli investitori stranieri e il sollevamento dell’intero comparto delle rinnovabili (che con l’indotto conta almeno 100.000 posti di lavoro) e finendo poi incagliato (notizia degli ultimi giorni) in Commissione Bilancio al Senato.] Come se non bastasse, l’Italia si ritrova a fare i conti ogni anno con la tara endemica della corruzione (10 miliardi di euro l’impatto sul PIL, secondo le stime più ottimistiche), della criminalità organizzata (arrivata a gestire un volume d’affari di oltre 100 miliardi di euro all’anno, con un impatto del 7% sul PIL) e dell’evasione fiscale (180 miliardi di euro, secondo uno studio commissionato lo scorso anno dal gruppo S&D del Parlamento Europeo). Senza contare le inefficienze di sistema, gli sprechi, etc., che oltre a un impatto reale sul prodotto interno contribuiscono a rendere meno agevole la vita delle persone, proprio nell’erogazione di quei servizi per cui annualmente offriamo in tasse il nostro contributo all’amministrazione dello Stato.
- Il crollo del Mezzogiorno prelude al baratro in cui sta scivolando l’Italia. Può essere comodo fornire i dati aggregati a livello di Paese, specie quando aiuta a mascherare le sue debolezze interne. Ma ancora una volta la semplificazione nasconde una realtà impietosa. Il rapporto della Banca d’Italia sulle Economie Regionali nel 2013 ci offre una fotografia della situazione e il quadro che ne emerge è atroce. Dal 2007 al 2013 il PIL è sceso del 7,1% in Italia e di ben il 13,5% nel Mezzogiorno. Dall’inizio della crisi, inoltre, le regioni meridionali sono le uniche ad aver registrato sempre il segno negativo nell’andamento del PIL: nemmeno l’illusione di una ripresa effimera registrata nel resto del Paese tra il 2010 e il 2011 ha alleviato le pene del Sud, che nel biennio 2012-2013 ha toccato il massimo della flessione con un netto e inappellabile -4%. Dal 2007 il Sud ha bruciato 43,7 miliardi di euro di PIL e 600.000 posti di lavoro. La metà dei posti di lavoro persi in Italia in questi sei anni è andata persa a Sud.
Insomma, non è che non se ne parli, ma nel migliore dei casi si tratta di notizie frammentarie, con dati forniti in quadri ipotetici di ripresa le cui fondamenta finiscono poi sempre per rivelarsi intrinsecamente fragili. Il governo Renzi gode, se non proprio di un endorsement, almeno di un credito fiduciario da parte dei principali organi d’informazione italiani (per non dire tutti), che consente di fornire cifre solo in una prospettiva comunemente accettabile. Come sia stato possibile imporre questo armistizio resta al momento dominio di speculazioni e sospetti, e forse non arriveremo mai a scoprirlo, ma non è di questo che voglio parlare.
I problemi vanno affrontati alla radice. Vi invito quindi a fare un passo indietro con me e tornare a inquadrare la situazione globale, su un intervallo storico più ampio. Il grafico qui in basso mostra l’andamento degli indicatori di produttività (in rosso) e occupazione (in blu) sul periodo 1947-2010. Le due curve procedono appaiate fino alla fine del secolo scorso. Da qualche parte intorno all’anno 2000 accade invece quello che Erik Brynjolfsson, docente alla Sloan School of Management del MIT, e il suo assistente Andrew McAfee hanno definito “the Great Decoupling“, vale a dire: il Grande Disaccoppiamento.
Il Grande Disaccoppiamento non invertirà la marcia, per il semplice motivo che i progressi nelle tecnologie dell’informazione non sembrano destinati a fermarsi. Sembra anzi che stiano accelerando. E potrebbe essere questa la buona notizia per la società. Il progresso tecnologico riduce i costi, migliora la qualità e ci proietta in un mondo in cui l’abbondanza diventa la norma.
Ma non esiste una legge economica che assicuri dal progresso benefici equamente distribuiti per tutti. Mentre la tecnologia scatta in avanti, potrebbe lasciarsi indietro molti lavoratori. Sulla breve distanza possiamo migliorare le loro prospettive principalmente investendo sulle infrastrutture, riformando la scuola ad ogni livello e incoraggiando gli imprenditori a inventare nuovi prodotti, servizi e industrie per creare nuove professioni.
Ma mentre facciamo questo, dobbiamo comunque iniziare a prepararci per una economia alimentata dalla tecnologia ancora più produttiva, che potrebbe non richiedere un grande apporto di lavoro umano. Progettare una società in salute compatibile con questa economia sarà la grande sfida, e la grande opportunità, della prossima generazione.
Dobbiamo riconoscere che la vecchia tendenza degli indicatori strettamente accoppiati è giunta a termine, e cominciare a pensare su come vorremmo che fosse la nuova tendenza.
Fino ad oggi abbiamo vissuto in una società basata sulla scarsità di risorse, ci ricordano Brynjolfsson e McAfee. È stato questo principio ad aver modellato l’economia su cui si regge il mondo in cui viviamo. Ma questo mondo potrebbe essere ormai giunto al crepuscolo. È impensabile continuare a ragionare secondo i vecchi schemi e modelli. La società sta cambiando inesorabilmente sotto la spinta delle forze della tecnologia, e le stesse forze stanno rimodellando il mondo della produzione. Per uscire dalla crisi potrebbe essere necessario cominciare a pensare secondo nuovi schemi di pensiero. O se non altro potrebbe risultare utile.
Un cambiamento di paradigma.
(fine prima parte – continua)
Un libro e un racconto. Per il tracciamento dei container trasportati via mare e lo scenario da guerra di spie in cui il Mediterraneo sta scivolando in Corpi spenti, ho derivato lo spunto di partenza da Guerreros di William Gibson.
Un altro debito importante è verso Samuel R. Delany (non è la prima volta, non sarà l’ultima) e il suo Sì, e Gomorra. A distanza di 47 anni dalla prima pubblicazione gli scenari delineati nel racconto, con le sottoculture urbane che fioriscono intorno allo sfruttamento sessuale degli spaziali in licenza, continuano a risultare una metafora insuperabile, soprattutto come rappresentazione delle alternative di utilizzo che la strada riesce sempre a trovare per le ricadute del progresso.
Uno dei punti-chiave del romanzo è la colonizzazione spaziale. Il che potrebbe sembrare paradossale, per un future noir che si svolge interamente per le strade di una metropoli e nei suoi bassifondi. Ma la Nuova Frontiera incombe sui personaggi e sulle loro storie. Tra i principali spunti che ho voluto approfondire nel libro c’è appunto l’approccio dell’umanità allo spazio: il modo in cui ci si arriva, il modo in cui la conquista dello spazio ci cambia. L’outer space si riversa nell’inner space, e come insegna J.G. Ballard il terreno di battaglia sono prima di tutto la nostra psiche e i nostri corpi.
Tre parole-chiave per l’approccio alla tecnologia in Corpi spenti: nichilismo, alienazione, paranoia.
 Immagini via Exonauts.
Immagini via Exonauts.
































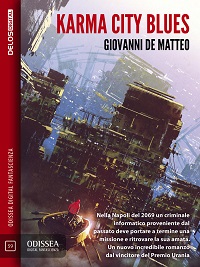


Interazioni recenti